Radici come rami

Radici come rami.
Da Rustschuk a Vienna, fino a Manchester e a Zurigo. Città, lingue, culture differenti. E libri. Tanti.
“Ogni volta che avevo finito un libro, ne discutevo con mio padre e talvolta mi eccitavo a tal segno che lui doveva calmarmi. Non mi disse mai però, come usano fare gli adulti, che le fiabe non sono vere; e di questo gli sono particolarmente grato, forse le considero vere ancora oggi.”
Quando a sette anni perde il padre, è la madre che lo sostituisce e accompagna Elias nel suo cammino di conoscenza. Insieme incontrano i grandi nomi della letteratura, ne discutono, e gli insegna il tedesco, lingua che parlava col marito.
È un legame intenso, quello con la mamma, un legame esclusivo. Che convive con l’ombra di un grido:
«Figlio mio, tu giochi e tuo padre è morto! Tu giochi, giochi, e tuo padre è morto! Tuo padre è morto! Tuo padre è morto! Tu giochi e tuo padre è morto!».
Grido che incide indelebilmente nella memoria di Elias l’incontro con la morte. Sarà presenza pesante e dolorosa, tanto da diventare tema costante, ossessivo, nelle sue opere.
La morte, il suo nemico. Il nemico dell’umanità.
Il primo viaggio autobiografico si ferma al 1921. È prosa sorprendente e ricca. Penetra con forza emotiva vigorosa e viva. Scorre ora come ruscello, ora come fiume in piena, con lucidità feroce o elegiaca tenerezza. Il lettore non può che seguirlo fin là, dove con la cacciata dal paradiso Elias nascerà alla vita.
Continuo a figurarlo con gli occhi rivolti ai cerchi scuri della tappezzeria, amici, compagni di gioco, di conversazione. E vorrei abbracciarlo.
“A casa, nella stanza dei bambini, giocavo per lo più da solo. In verità giocavo poco, parlavo piuttosto con la tappezzeria. I molti cerchi scuri nel disegno della tappezzeria li vedevo come persone. Inventavo una quantità di storie in cui essi figuravano da protagonisti, qualche volta ero io a raccontargliele, ma qualche volta anche loro partecipavano al gioco; comunque non mi stancavo mai di questi personaggi della tappezzeria ed ero capace di stare ore e ore a discorrere con loro.”
Quanta gratitudine dobbiamo a penne come la sua. Quanta!
 1
1

Buttate bussole e orologi, ché in questo viaggio non servono. Prendete invece una medaglia e osservatene le facce.
Il duca d’Auge sogna d’essere Cidrolin che sonnecchia nel barcone ormeggiato sulla Senna.
Cidrolin sogna d’essere il duca d’Auge.
Le vicende del duca si compiono con salti temporali di 175 anni, partendo dal 1264. Quelle di Cidrolin si svolgono nell’anno 1964.
Il duca e Cidrolin non potrebbero essere più diversi. L’uno feroce, senza scrupoli, sanguinario, l’altro sempre un po’ annebbiato, imbevuto di ”pernod” (essenza di finocchio); ridipinge lo steccato che qualcuno di notte riempie di scritte infamanti e poi si occupa della sua attività preferita: dormire. Sognare. Sulla sua chiatta, il suo barcone, la sua Arca.
Per conoscere le vicende del duca si deve attendere che Cidrolin s’addormenti, per seguire il sonnacchioso Cidrolin s’aspetterà che dorma il duca.
S’incontreranno. Nel 1964. Sull’Arca.
Il diluvio non è solo d’acqua.
I fiori blu è gioco fra sogno e realtà, fra vite che scorrono e cavalli che parlano. È viaggio in tondo al tempo e allo spazio, è succedersi di citazioni e metafore. È sfida, divertimento, baraonda entusiasmante. È fantasmagoria linguistica.
È faccenda contorta fin là, dove dal fango sbocciano piccoli fiori blu.
Anche le marce più oscure hanno una fine. Il Duca disse:
- Eccoci qua.
Si fermò. L’abate Riphinte l’imitò:
- Dove credete che siamo arriva-ti? - chiese il Duca.
- Nelle tenebre.
- E cosa vedremo?
- Poco o niente.
Salite sulla torre e poi lasciatevi andare. O cadere. Nel sogno, s’intende!

“Dicono che recitare è soltanto finzione. Questa finzione è la sola realtà”
Suo padre è il più bell’uomo d’Inghilterra, sua madre la più brava attrice. L’unico desiderio di Roger si chiama “realtà”.
Non li rimprovera, tuttavia il loro modo di vivere gli ha tolto la possibilità di credere in qualsiasi cosa.
Il ragazzo ricorda un episodio alla madre:
«Una sera, da ragazzino, avrò avuto quattordici anni, stavo tra le quinte a vederti recitare. Doveva essere una bella scena, tu dicevi le tue battute con tanta sincerità e quello che dicevi era così commovente che mi venne da piangere. Ero tutto sovreccitato, mi sentivo, non so come dire, elevato. Partecipavo alla tua sofferenza, mi sentivo un piccolo eroe; mi pareva che mai più avrei fatto un’azione bassa, meschina. E poi tu sei venuta in fondo alla scena, vicino a dov’ero io, con le lacrime che ti colavano sul viso; e dando la schiena al pubblico hai detto al direttore di scena, con la tua voce normale: cosa diavolo combina l’elettricista? gli avevo detto di togliere la luce blu. E un istante dopo ti sei girata verso il pubblico con un grido di angoscia e hai continuato la scena».
Julia replica:
«Tesoro, ma era una recita. Se un’attrice sentisse davvero le emozioni che rappresenta andrebbe in pezzi. Ricordo bene quella scena. Faceva crollare il teatro. Non ho mai avuto tanti applausi in vita mia».
Roger invece s’è sentito deriso, imbrogliato da questa madre inesistente, da questa donna ch’è solo le innumerevoli parti che ha interpretato.
Recitare è arte, e l’arte si crea. Nasce dalle vite di uomini e donne, dalle loro più piccole emozioni che prendono forma e sostanza in una dimensione nuova, dove illusione è il pubblico, realtà gli attori. L’attore è emblema del “trambusto vano e confuso che chiamano vita”.
La realtà inizia là, dove termina la quinta e comincia la scena. Fino a quando cala il sipario, e un altro si leva. Ben più grande, con un cast immenso, in una commedia senza fine.
Ecco l’ultimo trillo: “Pronti per andare in scena!”
 1
1
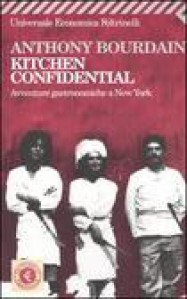
Ho consumato un barattolo di bicarbonato per arrivare alla fine (era una lettura condivisa, altrimenti avrei lasciato). E confesso, quando mi saliva lo schifo, qualche pagina l’ho saltata. Non ho uno stomaco così forte per reggere certi particolari.
Non ho colto l’utilità e nemmeno il senso di alcune descrizioni di Bourdain, cito come esempi lo sperma sulle scarpe del suo aiutante Steven, e le scopate di Steven-versione-porno con Chuletita loca, mentre, fra un grugnito e un asmatico quasi-orgasmo, telefona all’amico e collega Manuel, per chiedere: <i>“indovina che cosa sto facendo?”. Mi son parse fanfaronate.
Non penso che molteplici e sovrabbondanti porzioni di sesso, alcol, droga, imprecazioni e violenze varie, consumate in cucina per mano di un’orda di disadattati, arricchiscano il menu e facciano effetto WOW!, anzi, già al secondo giro si rischia lo “sbadiglio da ripetizione”. Insomma, più che trasgressione m’è parsa mera e fastidiosetta operazione di marketing.
Serpeggia odio puro per i vegetariani. Io sono vegana (addirittura!). Ma non mi sono sentita offesa né incompresa, quindi non replico. Sorvolo. E penso che difficilmente m’imbatterò in un lupanare gastronomico come quelli descritti.
Farò attenzione ai coltelli, coi quali ho un pessimo rapporto.
Non mi preoccuperò dei ristoranti narrati, che non frequento, ma spargerò la voce tra le mie conoscenze. Anche se forse sono più informate di me.
Dirò ai miei amici onnivori di quanto sia pericoloso mangiare pesce, e non solo, al ristorante il lunedì, e li informerò anche di tutto il resto. Grazie.
Il ritmo narrativo m’è piaciuto. Qualche perplessità sulla traduzione, ma non cercherò la versione in lingua. Ho già dato. E il bicarbonato è finito.
P.S. Sono una voce stonata. Il libro in realtà ha ottenuto enorme successo a livello mondiale, è stato tradotto in svariate lingue e ha ispirato una serie TV.
Ho trovato questa dichiarazione di Bourdain del 2017 a proposito della sua opera:
“To the extent which my work in Kitchen Confidential celebrated or prolonged a culture that allowed the kind of grotesque behaviors we’re hearing about all too frequently is something I think about daily, with real remorse.”
Un atto di pentimento, pare.
 1
1
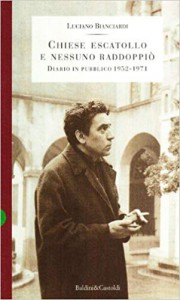
Caro Luciano,
oggi è caldo. Sudano le dita a scrivere, sudano le pagine da leggere. Sudano persino i pensieri. Secondo te, se mettessi una bacinella d'acqua fresca sotto la scrivania e un sottofondo di torrente, proseguirei a fare quel che fo illudendomi di goder la frescura all'ombra d'un arboscello?
Chissà cosa mi risponderesti.
Chiese escatollo e nessuno raddoppiò. Quante volte mi sono chiesta il significato di questo titolo, E non ci son mica arrivata sai? Ché poi il problema non era l’escatollo ma il corpulento “raddoppiò” con le sue doppie e panciute D e P. Leggevo, riponevo il libro, guardavo il titolo e lo interrogavo: Cosa mi vuoi significare?
Arrivata a pagina 106 son bastate due righe, due parole. Son bastati i barbagianni presi da bongiornite a farmi trovare il bandolo della matassa. E ho riso, riso e riso.
E poi, come sempre, il riso s’è fatto amaro. Perché la società che mira solo al profitto, che cerca, appena può, di fregare il prossimo; la società che considera il denaro più importante della vita come la raccontavi nel 1960 è tuttora così, nel 2018. Compresa la gara della bontà; però adesso dura meno, s’incattiviscono prima e mascherano peggio d’allora l’apparente dare senza contropartita. Esiste ancora il motto “comprate oggi, pagherete domani”. Anzi, pagherete tra un anno. Che il viaggio nella terra di Bengodi prosegue.
Il riso si fa amaro, perché ancora ce li mandiamo i liceali all’università sprovveduti e senza educazione alla vita politica e sociale, ancora senza conoscere la Storia, ancora digiuni di valori e d’ideali; ma anche ora basta poco a risvegliarli, entusiasmarli e renderli capaci di dar lezione di civiltà al sempiterno gregge di tartufi saccenti e moralisti. E questo fa ben sperare.
Quell’Italia sghemba che raccontavi, oggi è ancor più sghemba; il potere è ingordo più che mai. L’Italia è sfatta e ognuno si fa gli affari suoi.
I parlamentari hanno traslocato. Frequentano un altro palazzo adesso, detto Social Network. Lì si sfidano, s’insultano, s’accusano. Urlano. Fanno a gara a chi la spara più grossa. È un’arena pubblica. I cittadini assistono, parteggiano per questo o per quello, fanno da grancassa ai “rappresentanti del popolo”.
Nel ’69 scrivevi: “assisteremo a un vasto ritorno all'analfabetismo programmato”. Sapessi, risuona come un’eco senza fine.
Come vedi, in peggio, qualcosa è cambiato.
Invece I mesi dell’anno continuano a succedersi nel consueto ordine.
Leggerò, rileggerò, e inviterò a leggere Montale, Caproni, Zanzotto. E Gadda, Cassola, Parise, Pasolini, Arpino. Riprenderò Le ceneri di Gramsci e cercherò ciò che mi manca di London. Tornerò a Leopardi, Verga e Manzoni. Ne posso aggiungere qualcuno anch’io?
E continuerò a trovare rifugio nelle tue pagine. Ti fa piacere, almeno un po’?
Con le domande ho terminato.
Chissà cosa mi risponderesti.
Quanto amo il bianciardipensiero. Se solo t’avessero compreso, forse saresti rimasto ancora un po’.
Ciao Lucianone, alla prossima.
 1
1

Lo so, l’ha detto il mio amico Manga, che cominciare con un dunque virgola è villano.
Dunque, nella mia rubrica telefonica c’è il gruppo “defunti”. Ci finiscono i noiosi e gli urticanti, i supponenti e gli imbecilli, gli indigesti tutti. È una nutrita comitiva, quella che popola l’area “defunti”. Quando uno di loro chiama risuona la Marcia funebre per una marionetta di Gounod. Il “Ciao!” seguito dal nome del telefonante è sostituito da un “Prooonto!?” prolungato, antipatico, con l’ultima “O” che sale verso l’acuto e gela l’atmosfera, sicché il clima da inverno jacuziano impedisce qualsivoglia dialogo.
Chi se ne frega, direte voi. E avete ragione. Tuttavia, (altra insolenza grammaticale) serve a introdurre il mio pensiero sull’Elisir d’amore o La fiera delle ovvietà, il cui incipit recita così:
“Louise, se sei in ascolto, buongiorno.
Se non lo sei, addio.
A seconda della reazione che avrai, questo messaggio costituirà l’inizio o la fine del nostro scambio epistolare.”
Al posto di Louise avrei cestinato la mail, e Adam sarebbe finito all’istante tra i “defunti”. Così, con un clic. Com’è semplice, in certi casi, liberarsi dei fastidi.
Invece Louise ha risposto.
Leggo.
Mi deconcentro.
Quanti baci avrà mangiato? Che curiosa coincidenza: Louise è il nome dell’autrice delle missive e Luisa quello dell’ideatrice dei famosi baci, che inizialmente aveva battezzato “cazzotti” (giuro) ed erano privi di messaggi d’amore. Di quelli è responsabile un certo Seneca (il futurista, non il filosofo).
Rientro dalla digressione.
(Louise) se l’amicizia è la tomba dell’amore, odio l’amicizia.
(Adam) solo la pelle separa l’amore dall’amicizia. Ed è sottile...
(Louise) Ti pare sottile? A me sembra una muraglia.
E allora, Adam si spertica a spiegare alla poveretta che mentre il corpo decade la mente si fortifica, e che l’amicizia è conseguenza logica di un amore vero. Tradimenti a parte, bien sûr.
Lei, che si sentirebbe umiliata dell’amicizia post-amore, replica che preferisce la suite della passione al monolocale dell’affetto.
E lui, l’Adamo senza O, la rimbrotta. Louiselouiselouise, vuoi tutto? Precipiterai nel buio dell’infelicità, ingorda e frustrata che sei. Se pretendi la perfezione, è meglio che rinunci a vivere!
Louise non ticchetta più, lui si turba e digita:
“mi tieni il muso?
Mi stai odiando?
Mi hai dimenticato?”
E mi sovviene quella vecchia pubblicità d’una nota compagnia telefonica: “Mi ami? Ma quanto mi ami? Mi pensi? Ma quanto mi pensi?” Di nuovo distratta.
Mi riprendo.
L’Adamo parigino invia altre due righe due pregandola di rispondere anche mezza parola, altrimenti vola da lei. Non serve. Arriva la mail di Louise: 625 parole acidine, astiosette. Ma che nostalgia, che furtive lacrime! Figurarsi!
Lui di parole ne trasmette 400. Poi si torna alla parsimonia.
(Louise) Come te la passi? Raccontami le tue giornate. C’è un’altra donna?
(Adam) Non una donna, alcune donne. Nessuna può sostituirti, Louise.
E penso a Nemorino:
Ah! te sola io vedo, io sento
giorno e notte e in ogni oggetto:
d’obbliarti in vano io tento,
il tuo viso ho sculto in petto.
Col cambiarsi qual tu fai,
può cambiarsi ogn’altro amor.
Ma non può, non può giammai
il primero uscir dal cor.
Louise scrive al suo ex-caro-tuttavia-amico che prima d’apprezzare certe cose ci si deve abituare. Il caffè, le sigarette, i broccoli, la solitudine. Per esempio.
Non sono ancora a metà.
Scambi di confidenze sull’amore, sugli amori. Sulla psicanalisi. Su altro.
Sei geloso? Chiede lei.
(Adam): detesto la gelosia e sarei furioso se mi scoprissi geloso.
(Louise): si può essere padroni di ciò che si pensa, ma mai di ciò che si sente.
S’infastidisce lui. S’infastidisce lei. E nemmeno io scherzo.
Per fortuna è lettura di mezz’ora o poco più.
Forse quei baci avrebbero fatto meno danni se ingoiati con la loro carta argentata, ben sigillati, per impedire l’uscita dei famigerati bigliettini. Ché poi si prende spunto. Ahinoi.
Chiedo: scrivere questa roba, era indispensabile? Per aumentare il numero delle pagine, alcune contengono una sola riga scritta! Non è bello un libro fatto di niente e pagine bianche.
Eric,
(se dell’)“Elisir di sì perfetta,
di sì rara qualità,
ne sapessi la ricetta,
conoscessi chi ti (la) fa” (perdona, Felice, questa mia sfacciataggine)
basterebbe una goccetta
a rimuover l’ovvietà
e da storia noiosetta
otterresti una beltà.
P.S. Peccato. Di Schmitt avevo letto altri libri, leggeri ma non banali. Questo sa di filosofia da supermercato (con tutto il rispetto per i supermercati).
Oppure sono io incapace di cogliere. Perché no.
 2
2
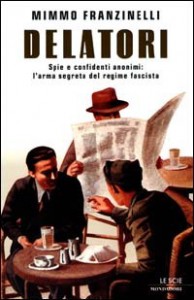
“Ho avuto montagne di lettere anonime, come si può pretendere di togliere agli italiani le loro caratteristiche nazionali, vigliaccheria e falsità cordiale?” (capitano S.A., ufficiale della Polizia politica della RSI, in servizio a Milano e a Torino)
Questa è la storia della bassezza morale di migliaia d’italiani: persone comuni, avvocati, professori, clericali, rabbini, ebrei, gerarchi, ricchi e poveri che volontariamente si fecero confidenti del regime. Per denaro, per gloria, per cattiveria.
Il fenomeno delle delazioni nell’Italia di Mussolini arrivò a livelli mai visti. A iniziare dal ’26, con l’entrata in vigore di nuove leggi, divenne reato punibile con avari gradi di severità criticare il duce e il regime, detenere o diffondere stampa antifascista, esprimere dissenso o malcontento. Negli anni ’30 si aggiunsero i provvedimenti antisemiti e dall’entrata in guerra fino alla caduta del fascismo, aumentando gli oppositori del regime, crebbe il numero dei soggetti perseguibili. Manna dal cielo per i delatori.
L’informatore riceveva, in cambio della soffiata, denaro o beni alimentari, e se la denuncia era sottoscritta, si garantiva la segretezza.
La delazione non fu solo fonte di guadagno, fu anche strumento per salire di un gradino la scala gerarchica, prendere possesso dei beni altrui, ottenere favori. In qualche caso salvarsi la pelle.
Ecco così fascisti mettere in cattiva luce camerati per ottenere un riconoscimento, partigiani passare (per paura o interesse) agli ufficiali della Polizia politica notizie sui propri compagni; ecco commercianti, liberi professionisti e funzionari liberarsi della concorrenza denunciando i colleghi, preti e rabbini offrire collaborazione in cambio di vantaggi materiali; e ancora, ecco ebrei guadagnare 7000 lire per ogni ebreo fatto catturare, e cittadini accusare familiari per vendicarsi di vecchie questioni. Insomma, dichiarare un rivale “nemico della Patria” costava niente e tributava parecchio.
I delatori senza volto agivano per denaro, odio razziale, fanatismo, invidia, vendetta, ambizione. Si firmavano <i>“Un gruppo di fascisti”, “Una camicia nera della prima ora”, “Un fedele suddito del Duce”. Si dichiaravano buoni cittadini. Con le mani pulite e la coscienza lercia, però.
Il regime sfruttò e premiò generosamente migliaia d’italiani che volontariamente contribuirono all’arresto, alla tortura, alla deportazione di tante vittime innocenti.
Il pensiero d’essere corrotti e traditori, i delatori, nemmeno li sfiorò. Forse mancavano di quello spessore morale che rende Uomini gli uomini, Donne le donne.
Il lavoro imponente di Mimmo Franzinelli scopre un tassello infimo e vergognoso della nostra Storia.
Com’è stato possibile per il nostro Paese rialzarsi? Si fa breccia un interrogativo che stizzisce chi vorrebbe cancellare la parte scomoda della Storia: la dimenticanza di “faccende” che avrebbero indebolito l’identità civica del popolo italiano “aiutò la risalita?”.
Dovremmo sforzarci di riconoscere che se tanti furono gli italiani che aiutarono, protessero e salvarono ebrei, renitenti, partigiani, se tanti furono quelli che combatterono il regime e sacrificarono la vita per la libertà, tanti (troppi) furono quelli che collaborarono col regime per saziare i propri egoismi. Non possiamo continuare imperterriti a puntare il dito contro gli altri pensando che basti a cancellare le colpe gravissime di cui fummo responsabili. Smettiamola con la favola ipocrita del “cattivo tedesco” e del “buon italiano”. Prendiamo atto di quanto è stato e diciamolo, perdio!: italiani brava gente, ma non tutti.
Questo è un libro da leggere. Aprire gli occhi significa intraprendere un percorso di consapevolezza. È un cammino che dobbiamo affrontare. Non tradiamo la Storia, togliamo di sotto il tappeto le nostre ignominie. Guardiamole, affrontiamole. Rinnegare, tacere o semplicemente chiudere gli occhi non ci rende meno spregevoli di quei delatori.
Termino riportando un episodio (fra i tanti) a memoria di chi dimostrò grande integrità morale. Gesti nobili che devono esortarci a rappresentare la parte migliore degli esseri umani. È la testimonianza di un sacerdote che vegliò per un momento il cadavere del comunista Vito La Fratta, di Sesto San Giovanni, incarcerato a San Vittore il 3 maggio 1944. Fu pestato e torturato dai funzionari dell’Ufficio politico investigativo. Due giorni dopo il suo nome fu depennato dal registro matricolare perché “deceduto”:
“Sono entrato nella cella e sono rimasto solo con l’impiccato ch’era stato disteso già sulla branda: un bel ragazzone robusto, dai capelli d’oro e dagli occhi celesti; sembrava un principe di fiaba vestito da galeotto. Ma gli occhi erano rimasti spalancati ed erano immobili e freddi, così freddi che facevan male a guardarli.
Avrà avuto poco più di trent’anni ed era sposato ed aveva già un amore di bimba. E non s’è impiccato per disperazione, ma per non fare male agli altri, per non tradire nessuno. Aveva già subito tre interrogatori, durante i quali era stato atrocemente torturato perché parlasse, perché dicesse i nomi che interessavano gli aguzzini della Polizia speciale. Ed egli sempre muto. A mezzogiorno l’avevano cacciato a furia di calci fuori della camera dell’interrogatorio. Non si reggeva più in piedi, sicché i compagni hanno dovuto sostenerlo e accompagnarlo fino alla sua cella che è al primo piano rialzato del sesto raggio. Tuttavia appena giunto al suo piano, ha tentato di proseguire e, raccogliendo tutte le sue forze, s’è slanciato per le scale con il proposito evidente di buttarsi giù dal più alto terrazzino interno che gira intorno alle celle dell’ultimo piano. I compagni lo hanno raggiunto e ricondotto nella sua cella. Ed egli smaniava e supplicava: “Fatemi morire! Aiutatemi a morire! Alle 4 devo presentarmi ancora all’interrogatorio e non ho più forza, non potrò più resistere, finirò col parlare, non devo parlare, non voglio parlare, non voglio tradire nessuno! Aiutatemi a morire! Datemi qualche cosa! Almeno una lametta di rasoio...”.
I compagni cercarono di calmarlo, gli fecero iniettare della morfina per alleviargli i dolori, gli dettero un po’ di cognac, lo convinsero a buttarsi sul pagliericcio per riposare: “Prima delle 4 verremo noi a svegliarti e ti daremo del cognac”.
Prima delle 4 andarono a svegliarlo e lo trovarono appeso all’inferriata della finestra. S’era impiccato con un pezzo di fil di ferro, forse trovato tra la spazzatura della cella.
Povero ragazzone biondo dai begli occhi celesti senza vita... Mi sono avvicinato per chiudergli quegli occhi che mi sembravano stanchi di contemplare la barbarie degli uomini, che lo avevano spinto al suicidio. Mi sono avvicinato per accarezzargli la fronte bianca come il marmo sotto l’onda dei capelli d’oro, e ho visto un piccolo dettaglio che mi ha riempito di ribrezzo. La sua fronte e la guancia destra erano stampigliate col timbro delle carceri... Gli aguzzini, a mezzogiorno, non si erano accontentati di torturarlo, ma l’avevano ferocemente dileggiato stampigliandogli (certo con grandi colpi) il timbro sulla faccia. Cosicché, su quel volto sigillato dalla morte, si leggeva: “CARCERI GIUDIZIARIE – MILANO”.
Ed era un tremebondo e incancellabile atto di accusa contro coloro che l’avevano spinto a quell’eccesso.”
 2
2
E Baistrocchi aveva pensato “Ma pensa”

E Baistrocchi aveva pensato “Ma pensa”.
Ho letto, e adesso son qui a scrivere, cioè, non come voi comici che si potrebbe chiamarvi anche romanzer perché scrivete romanzi, ma a scrivere quattro righe su Undici treni. Che forse scrivere undici righe su Undici treni sarebbe anche più corretto, almeno non resterebbero sette treni senza righe. E dimmi che ai treni è meglio che gli manchino le righe invece che i binari, zio campanaro. Absit iniuria verbis.
Ma sai quanto mi piacerebbe fare un salto al Tristobar correndo persino il rischio di dirti siedo anch’io e sentirmi dire no tu no? E senza un perché, così, solo perché no. Va’ che scherzo. Che poi, non potrei neanche incolparti che se c’è uno scherzo è del destino, che poi non sai nemmeno dove sta questo destino per andarlo a cercare per chiedergli perché. Un po’ come l’Augusto Stracciari che quando si chiamava Augusto Stracciari era nato a Medicina e però quando abitava con la regione dell’Asia minore abitava in via Squadroni e si chiamava Arturo Mezzadri, poi quando aveva deciso che non era nato a Medicina ma a Ospitaletto non era più l’Augusto Stracciari che era nato a Medicina ma era uno nuovo che si era fatto persino crescere i capelli. Cosa c’entra mi dirai. Se non lo sai te.
Come mi piacerebbe incontrarvi, compresa la regione dell’Asia minore. Che bello. Figo. Di più.
Chiederei a Speedy Perquindi un succo d’arancia giusto perché te avevi chiesto il succo d’arancia e lui aveva preso quello d’ananas, e te l’avevi guardato male che eri appena uscito di prigione e lui non sapeva che eri appena uscito di prigione e alla fine aveva detto ah ho capito. E io apposta chiederei a Perquindi il succo d’arancia per vedere se si sbaglia anche con me, così lo guarderei male anch’io anche se non sono appena uscita di prigione, che a dire il vero io proprio non ci sono mai stata in prigione, ma guardo male anch’io e quando guardo male faccio effetto, e alla fine magari direbbe anche a me ah ho capito.
E mi piacerebbe fare chiacchiering, lì seduti al Tristobar. Due parole. Ma anche due silenzi.
E sai che ridere a giocare alle espressioni parassite? Che noi non ci pensiamo ma alla fine siamo tutti pieni di espressioni parassite. Che se c’è un patto, è di stabilità, se c’è una risata è contagiosa, se c’è un freddo è polare, se ci sono dei sogni, son nel cassetto. Ben chiusi, sempre. Poverini. I sogni, dico. Che poi dico dico e invece sto scrivendo.
E alla fine vi saluterei tutti e direi parto, e Perquindi direbbe anche a me: «Perquindi vai via?» e io gli risponderei: «Perquindi sì».
E adesso siccome ho scritto più di quattro righe e vorrei fare pausing, se ti fa niente farei zapping e magari stopping su To soréla entertainment.
Ecco.
Per farla breve, la vita è fatta di treni, tutti da prendere. Però, a pensarci su un momento, l’ultimo treno, quello lì sarebbe bello perderlo, zio campanaro. Absit iniuria verbis.
E infine grazie che mancano le “d” eufoniche e che in La meravigliosa utilità del filo a piombo hai chiamato clarinetti i clarinetti (lo so che non c’entra niente con Undici treni ma lo metto qui lo stesso, perché quando ho letto clarinetti mi si è allargato un sorriso che non hai idea). Che io ci ho il sobbalzo facile e vederli scambiati per clarini puoi immaginarti.
E niente. Son soddisfazioni.
Stravagante, arruffato, sagacemente sgrammaticato.
Il suo sguardo si posa sul mondo e sulla gente, sulle piccole gioie e i drammi della vita con ironia e umanità.
“Insomma a lui, a Baistrocchi, gli piaceva lamentarsi, per esempio una volta, mentre scendeva le scale che stava venendo al Tristobar, noi ci trovavamo tutte le sere, o quasi tutte le sere, al Tristobar, così lui mi raccontava le cose e io lo ascoltavo e gli davo ragione e una sera, Baistrocchi, gli era suonato il telefono, aveva risposto, era un giornalista del Corriere della sera, edizione di Bologna, che gli aveva detto «Senta, ma lei, cosa ne dice di questo calo delle iscrizioni a lettere, all’università?»
E lui, che non sapeva niente, del calo delle iscrizioni a lettere, all’università, gli aveva risposto: «Niente, ne dico, del calo delle iscrizioni a lettere, all’università. Mi chiedo soltanto come mai lo chiede a me» gli aveva detto.
«Ma scusi» gli aveva detto il giornalista del Corriere della Sera, edizione di Bologna, «ma lei non è un letterato?»
«E lei non è un giornalista?» gli aveva chiesto lui.
«Sì» gli aveva detto il giornalista.
«E io le ho forse chiesto di dirmi qualcosa del calo delle vendite dei giornali?»
«No» gli aveva detto il giornalista «non me l’ha chiesto».
«Ecco» gli aveva detto Baistrocchi, mi aveva raccontato Baistrocchi tutto contento.
Zio campanaro, che testa che aveva.”
 1
1

“Non conosceva nulla, né si conosceva; viveva per vivere, e non sapeva di vivere; gli batteva il cuore, e non lo sapeva; respirava, e non lo sapeva; moveva le pàlpebre, e non se n’accorgeva.”
Pirandello inizia a lavorare a Uno nessuno centomila nel 1909. La prima puntata dell’opera uscirà nel 1925 sulla “Fiera letteraria”.
Il dramma di Vitangelo Moscarda comincia quando la moglie fa una considerare sulla piccola imperfezione del suo naso. Davanti all’immagine riflessa personalità e realtà si frantumano: Vitangelo Moscarda non è, per gli altri, quello che egli si crede. Avvia così un fitto monologo che mette in luce la molteplicità dell’essere.
Ma per Vitangelo, chi è Vitangelo Moscarda? Sinora aveva creduto d’essere uno.
“A chi dire «io»? Che valeva dire «io», se per gli altri aveva un senso e un valore che non potevano mai essere i miei; e per me, così fuori degli altri, l’assumerne uno diventa subito l’orrore di questo vuoto e di questa solitudine?”
Si ribella, Vitangelo. Inizia a compiere azioni che scombinano e rovesciano ogni certezza sul suo apparire. Cerca disperatamente di dimostrare di non essere quello che gli altri credono.
– Pazzo! Pazzo! Pazzo!
Era lo stesso grido di tutta la folla lì davanti la porta:
– Pazzo! Pazzo! Pazzo!
Perché avevo voluto dimostrare, che potevo, anche per gli altri, non essere quello che mi si credeva.
Credeva d’essere uno, scoprì d’essere centomila, decise d’essere nessuno. Scivolò nella follia (follia?) per trovare riparo, salvezza e liberazione, per morire e rinascere ogni giorno, nuovo e completo.
P.S. Camminando ho guardato improvvisamente una vetrina per catturare l’io che non conosco. Pirandello, Pirandello!
 1
1

C’è chi lo pensa morto nel suo bunker, chi fuggito in sud America; e invece è in casa Abbate a tinteggiare le pareti. Ma che soggetto distratto e scansafatiche quest’omino, certo Adolf Hitler, che il piccolo Fulvio deve chiamare zio, su ordine del nonno. E quella gran testa di scienziato che dicono scomparso nel ’38? Lui, sì, Ettore Majorana. Anch’egli in casa Abbate, a progettare un missile, la V3 che dovrebbe portare a Parigi i membri della famiglia Politi-Priolo-Abbate-Sicuro a Parigi, e che, nel frattempo, esce vestito da suora e dà ripetizioni di aritmetica al piccolo Fulvio. Tutto questo nella Palermo degli anni ’60. Realtà e fantasia tessono una trama surreale, fantasmagorica, colorata.
Lo sguardo limpido del piccolo Fulvio si posa sul mondo. E lo racconta con la semplicità e la bellezza proprie dei bambini. Per chi legge è meraviglia, è un salto indietro nel tempo, è il rincorrere questa girandola di personaggi e fatti irreali e in fondo più verosimili di tanti veri (veri?).
È un viaggio negli affetti, è un viaggio d’amore per papà Totò e il suo “Quattroruote”, che rimboccherà le coperte al figlio finché riuscirà a farlo; per mamma Gemma, insegnante e bugiarda indefessa che gli trasmetterà l’amore per la Francia, dove si recheranno veramente; e amore per gli zii e i nonni che arricchiscono, con la loro presenza, la famiglia Abbate.
È un viaggio pieno di vita, anche se a ben pensarci è la morte a essere protagonista. Ma lo è in modo lieve, delicato, “felice”. Vivo.
E infine è un viaggio nella libertà, quella che appartiene ai bambini, quella libertà che li rende speciali. E allora sì, alla domanda “cosa farai da grande” dovremmo rispondere “il bambino”. Perché i bambini sono liberi, i bambini non hanno paura né vergogna di sognare. E nemmeno di commuoversi.
Restiamo bambini. Proviamoci. Manteniamo sguardo limpido e aperto all’incanto. E per chi cercherà di demolire tutto, suca!
 1
1

“Non conosceva nulla, né si conosceva; viveva per vivere, e non sapeva di vivere; gli batteva il cuore, e non lo sapeva; respirava, e non lo sapeva; moveva le pàlpebre, e non se n’accorgeva.”
Pirandello inizia a lavorare a Uno nessuno centomila nel 1909. La prima puntata dell’opera uscirà nel 1925 sulla “Fiera letteraria”.
Il dramma di Vitangelo Moscarda comincia quando la moglie fa una considerare sulla piccola imperfezione del suo naso. Davanti all’immagine riflessa personalità e realtà si frantumano: Vitangelo Moscarda non è, per gli altri, quello che egli si crede. Avvia così un fitto monologo che mette in luce la molteplicità dell’essere.
Ma per Vitangelo, chi è Vitangelo Moscarda? Sinora aveva creduto d’essere uno.
“A chi dire «io»? Che valeva dire «io», se per gli altri aveva un senso e un valore che non potevano mai essere i miei; e per me, così fuori degli altri, l’assumerne uno diventa subito l’orrore di questo vuoto e di questa solitudine?”
Si ribella, Vitangelo. Inizia a compiere azioni che scombinano e rovesciano ogni certezza sul suo apparire. Cerca disperatamente di dimostrare di non essere quello che gli altri credono.
– Pazzo! Pazzo! Pazzo!
Era lo stesso grido di tutta la folla lì davanti la porta:
– Pazzo! Pazzo! Pazzo!
Perché avevo voluto dimostrare, che potevo, anche per gli altri, non essere quello che mi si credeva.
Credeva d’essere uno, scoprì d’essere centomila, decise d’essere nessuno. Scivolò nella follia (follia?) per trovare riparo, salvezza e liberazione, per morire e rinascere ogni giorno, nuovo e completo.
P.S. Camminando ho guardato improvvisamente una vetrina per catturare l’io che non conosco. Pirandello, Pirandello!
Videoassaggi. Un libro in cinque morsi
 1
1

E Baistrocchi aveva pensato “Ma pensa”.
Ho letto, e adesso son qui a scrivere, cioè, non come voi comici che si potrebbe chiamarvi anche romanzer perché scrivete romanzi, ma a scrivere quattro righe su Undici treni. Che forse scrivere undici righe su Undici treni sarebbe anche più corretto, almeno non resterebbero sette treni senza righe. E dimmi che ai treni è meglio che gli manchino le righe invece che i binari, zio campanaro. Absit iniuria verbis.
Ma sai quanto mi piacerebbe fare un salto al Tristobar correndo persino il rischio di dirti siedo anch’io e sentirmi dire no tu no? E senza un perché, così, solo perché no. Va’ che scherzo. Che poi, non potrei neanche incolparti che se c’è uno scherzo è del destino, che poi non sai nemmeno dove sta questo destino per andarlo a cercare per chiedergli perché. Un po’ come l’Augusto Stracciari che quando si chiamava Augusto Stracciari era nato a Medicina e però quando abitava con la regione dell’Asia minore abitava in via Squadroni e si chiamava Arturo Mezzadri, poi quando aveva deciso che non era nato a Medicina ma a Ospitaletto non era più l’Augusto Stracciari che era nato a Medicina ma era uno nuovo che si era fatto persino crescere i capelli. Cosa c’entra mi dirai. Se non lo sai te.
Come mi piacerebbe incontrarvi, compresa la regione dell’Asia minore. Che bello. Figo. Di più.
Chiederei a Speedy Perquindi una spremuta d’arancia giusto perché te avevi chiesto il succo d’arancia e lui aveva preso quello d’ananas, e te l’avevi guardato male che eri appena uscito di prigione e lui non sapeva che eri appena uscito di prigione e alla fine aveva detto ah ho capito. E io apposta chiederei a Perquindi il succo d’arancia per vedere se si sbaglia anche con me, così lo guarderei male anch’io anche se non sono appena uscita di prigione, che a dire il vero io proprio non ci sono mai stata in prigione, ma guardo male anch’io e quando guardo male faccio effetto, e alla fine magari direbbe anche a me ah ho capito.
E mi piacerebbe fare chiacchiering, lì seduti al Tristobar. Due parole. Ma anche due silenzi.
E sai che ridere a giocare alle espressioni parassite? Che noi non ci pensiamo ma alla fine siamo tutti pieni di espressioni parassite. Che se c’è un patto, è di stabilità, se c’è una risata è contagiosa, se c’è un freddo è polare, se ci sono dei sogni, son nel cassetto. Ben chiusi, sempre. Poverini. I sogni, dico. Che poi dico dico e invece sto scrivendo.
E alla fine vi saluterei tutti e direi parto, e Perquindi direbbe anche a me: «Perquindi vai via?» e io gli risponderei: «Perquindi sì».
E adesso siccome ho scritto più di quattro righe e vorrei fare pausing, se ti fa niente farei zapping e magari stopping su To soréla entertainment.
Ecco.
Per farla breve, la vita è fatta di treni, tutti da prendere. Però, a pensarci su un momento, l’ultimo treno, quello lì sarebbe bello perderlo, zio campanaro. Absit iniuria verbis.
E infine grazie che mancano le “d” eufoniche e che in La meravigliosa utilità del filo a piombo hai chiamato clarinetti i clarinetti (lo so che non c’entra niente con Undici treni ma lo metto qui lo stesso, perché quando ho letto clarinetti mi si è allargato un sorriso che non hai idea). Che io ci ho il sobbalzo facile e vederli scambiati per clarini puoi immaginarti.
E niente. Son soddisfazioni.
Stravagante, arruffato, sagacemente sgrammaticato.
Il suo sguardo si posa sul mondo e sulla gente, sulle piccole gioie e i drammi della vita con ironia e umanità.
“Insomma a lui, a Baistrocchi, gli piaceva lamentarsi, per esempio una volta, mentre scendeva le scale che stava venendo al Tristobar, noi ci trovavamo tutte le sere, o quasi tutte le sere, al Tristobar, così lui mi raccontava le cose e io lo ascoltavo e gli davo ragione e una sera, Baistrocchi, gli era suonato il telefono, aveva risposto, era un giornalista del Corriere della sera, edizione di Bologna, che gli aveva detto «Senta, ma lei, cosa ne dice di questo calo delle iscrizioni a lettere, all’università?»
E lui, che non sapeva niente, del calo delle iscrizioni a lettere, all’università, gli aveva risposto: «Niente, ne dico, del calo delle iscrizioni a lettere, all’università. Mi chiedo soltanto come mai lo chiede a me» gli aveva detto.
«Ma scusi» gli aveva detto il giornalista del Corriere della Sera, edizione di Bologna, «ma lei non è un letterato?»
«E lei non è un giornalista?» gli aveva chiesto lui.
«Sì» gli aveva detto il giornalista.
«E io le ho forse chiesto di dirmi qualcosa del calo delle vendite dei giornali?»
«No» gli aveva detto il giornalista «non me l’ha chiesto».
«Ecco» gli aveva detto Baistrocchi, mi aveva raccontato Baistrocchi tutto contento.
Zio campanaro, che testa che aveva.”i>
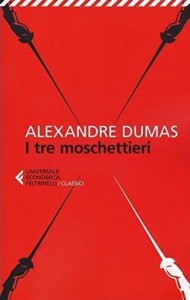
Tous pour un, un pour tous.
Rimestando fantasia e verità nella coppa della menzogna temporale, non poteva che andar così.
Sono tre: Athos, Porthos e Aramis. Quando arriva il giovane e impulsivo guascone d’Artagnan, l’avventura prende vita in un evolversi rapido, rocambolesco, appassionante.
Dumas è così abile a usare la penna della leggerezza che non c’è trasalimento per le imprecisioni storiche, né raccapriccio per i sanguinosi duelli o per le feroci dipartite. Si occhieggia, invece, con sorriso compiaciuto, alle audaci “capatine”. E sfugge un risolino divertito guardando il noioso Luigi XIII controllare i fermagli di diamanti della sua sposa, e ancor più rivolgendo lo sguardo al diabolico cardinale.
Ah, gli amori, gli amori! I tradimenti, i tradimenti! Ah, gli intrighi, gli intrighi!
“Li si vedeva avanzare a braccetto, occupando tutta la larghezza della strada e avvicinandosi a ogni moschettiere che incontravano, tanto che alla fine la loro fu una marcia trionfale. Il cuore di d’Artagnan sguazzava nell’ebbrezza, mentre camminava fra Athos e Porthos abbracciandoli teneramente.”
E come quei parigini che dal 14 marzo al 14 luglio 1844 attesero ogni giorno l’uscita del giornale Le siècle per leggere incantati le avventure del cadetto di Guascogna e i tre moschettieri, anch’io non ho mancato al mio appuntamento quotidiano, Monsieur Dumas. Per la seconda volta.
Siete un geniaccio, ve l’ho già detto. Però, vogliamo fare i complimenti anche al buon Auguste Maquet? Li merita, vi pare?
E ogni volta mi chiedo se l’avete pagato.
 1
1
Priapo Ottimo Massimo, o il Fallo in camicia nera

Priapo Ottimo Massimo, o il Fallo in camicia nera.
“Ergo: la Italia ventitré anni quello animalino la mandò. E che il giudice mi tagli mano, se questo che qui non è sillogismo diritto, di misura stretta. Il suggeritore fu lui il Ministro, Primo Ministro delle bravazzate, lui il Primo Maresciallo (Maresciallo del cacchio), lui il primo Racimolatore e Fabulatore ed Ejettatore delle scemenze e delle enfatiche cazziate, quali ne sgrondarono giù di balcone ventitré anni durante”
Gadda, ch’era stato iscritto al partito fascista, affermò che già con la guerra d’Etiopia aveva compreso cos’era veramente il fascismo e quanto lo ripugnava, “Prima non me n’ero mai occupato. Le camicie nere mi davano fastidio e basta”. Arrivò la sua condanna con Eros e Priapo, un furioso attacco contro il duce, i suoi gerarchi, gli uomini e le donne fasciste. E contro se stesso, che tanto nel fascismo aveva creduto.
Del Batrace tritacco scrive:
“Ed ebbe faccia da proferire, notate, da proferire verbalmente, con l’apparato laringo-buccale la sporca e bugiarda equazione: io sono la patria; e l’altra: io sono il pòppolo.”
Così, lo sbraitante mascelluto dux piccavasi d’impersonare egli solo la causa, la patria e il suo poppppolo con quattro p che vociava da sotto il poggiolo: ku-ce ku-ce ku-ce!
È sconcio sconcissimo turpiloquio, violentissimo attacco, invettiva furente. È analisi feroce e lucida della psicologia del fascismo e del popolo italiano. È satira a livelli altissimi. È lingua possente e magnifica contaminazione: Machiavelli, fiorentino odierno, escursioni nel parlato lombardo e romano.
Non è lettura facile, ma affrontare quest’iconoclastica mussolineide vale davvero la pena.
“Eretto ne lo spasmo su zoccoli tripli, il somaro dalle gambe a ìcchese aveva gittato a Pennino ed ad Alpe il suo raglio. Ed Alpe e Pennino echeggiarlo, hì-hà, hì-hà, riecheggiarlo infinitamente hè-jà, hè-jà, per infinito cammino de le valli (e foscoliane convalli): a ciò che tutti, tutti!, i quarantaquattro millioni della malòrsega, lo s’infilassero ognuno nella camera timpanica dell’orecchio suo, satisfatto e pagato in ogni sua prurigo, edulcorato, inlinito, imburrato, imbesciamellato, e beato. Certi preti ne rendevano grazie all’Onnipotente, certi cappellani di cappellania macellara; certe signore, quella sera, “si sentivano l’animo pieno di speranza”. A chiamarlo animo, il sedano, e a chiamarla speranza, chel sugo.”
“Che sarebbe mai la nostra povera Italia senza quell’omo!”
Poteva essere la storia di un granello smargiasso. Invece fu sciagura infame e rivoltante. Hè-jà hè-jà trallallà.
 1
1

Contrariamente alla storiografia sulla rivoluzione bolscevica, che contesta l’immagine mitica della rivoluzione d’ottobre, ma non la riduce a un’opera grottesca, in Italia gli storici dibattono ancora, senza trovare accordo, sul significato storico della “marcia su Roma”. Salvemini la definì “opera buffa”, Repaci pur affermando che la conquista fascista del potere racchiudeva in sé il fenomeno fascista e tutto ciò che vi gravitava attorno, riteneva la “marcia su Roma” una “goffa kermesse”; Sassoon, in Come nasce un dittatore, le cause del trionfo di Mussolini, la considera “poco più che una trascurabile adunata di utili idioti”. Anche gli antifascisti dell’epoca sottovalutarono la “marcia su Roma” e quando il regime li schiacciò e li mise al bando “si consolarono ridicolizzando la «marcia su Roma» come una messa in scena, e proiettarono questa immagine su tutta la successiva esperienza del regime totalitario”.
Minimizzarono il fenomeno (e ancora oggi qualcuno lo riduce a fatto di poco conto) che, in realtà, fece precipitare il Paese in uno dei periodi più bui della storia italiana, il tragico ventennio di regime, sconfitto soltanto “dopo essere stati sopraffatti e disfatti dagli eserciti stranieri in una seconda guerra mondiale”.
Harry Kessler, diplomatico tedesco e acuto osservatore, confrontando le due rivoluzioni da cui nacquero i primi regimi a partito unico, il 29 ottobre 1922 riportava nel suo diario: “In Italia i fascisti hanno conquistato il potere con un colpo di Stato. Se riusciranno a conservarlo, allora questo è un evento storico che potrà avere conseguenze imprevedibili non solo per l’Italia ma per l’intera Europa. Può essere il primo passo verso la vittoria avanzata della controrivoluzione. Fino ad oggi i governi controrivoluzionari hanno agito, in Francia per esempio, come se fossero democratici e amanti della pace. In Italia, invece, si afferma un tipo di governo francamente antidemocratico e imperialista. Il colpo di Stato di Mussolini può essere paragonato a quello di Lenin nell’ottobre 1917, ma diretto in senso opposto, naturalmente. E può darsi che sfocerà in un periodo di nuovi disordini e di guerre in Europa”
La mattina del 30 ottobre, Mussolini scese dal treno alla stazione di Roma. Alla folla rivolse le seguenti parole: “Sono venuto a Roma per dare un governo alla Nazione. Tra poche ore la Nazione non avrà solo un ministro: avrà un governo”. In realtà l’Italia si preparava a subire un regime. Un partito di milizia conquistò il governo di uno Stato parlamentare, dopo tre anni di esistenza come movimento e uno soltanto come partito. La violenza sostituì esperienza e conoscenza di amministrazione e governo, l’astuzia raggirò politici e governanti navigati, tolse “il monopolio della forza, l’autorità e il prestigio a uno Stato che era uscito vincitore dalla prova di una guerra mondiale; e alla fine riuscì a conquistare il potere proclamando apertamente che l’avrebbe usato per distruggere lo Stato liberale e la democrazia”.
Violento e ambizioso, capace oratore, prima esponente socialista e direttore dell’Avanti, poi fondatore de Il Popolo d’Italia e nemico degli ex compagni, presentò il fascismo come movimento “antipartito”, repubblicano e anticlericale, difensore della vittoria, ostile al socialismo. In seguito, per aumentare il consenso, diede un nuovo volto, un nuovo taglio ideologico, una nuova immagine. Evidenziò l’orientamento a destra, dichiarò che il fascismo era la forza più attiva in difesa della “borghesia produttiva”; divenne rispettoso del cattolicesimo perché esso faceva di Roma, per lui “ capitale di un immenso Impero spirituale”, che parlava “a 400 milioni di uomini”, quindi utile all’azione espansionista del fascismo.
Partì l’offensiva degli squadristi. Incendiarono e devastarono edifici e documenti, spararono contro chi professava idee socialiste e contro semplici cittadini, forti del favore che godevano da parte di prefetti, questori, funzionari di polizia, ufficiali militari, magistrati, quasi tutti favorevoli al fascismo.
Il governo non reagì. Quando il Popolo d’Italia pubblicò il regolamento della milizia fascista, il capo di gabinetto porse il giornale al ministro dell’Interno e chiese: “Cosa ne pensi? Se il Governo dopo questa sfida se ne sta alla finestra, come ha fatto finora, si coprirà di ridicolo”. Il ministro gli consegnò un foglio che conteneva le sue dimissioni, dichiarando: “Se al Consiglio dei ministri non si approvano le misure che io esporrò per tentare di uscire da questa situazione umiliante, me ne vado”. Ma il Consiglio dei Ministri non prese posizione, e il ministro degli Interni, invitato a non creare una nuova crisi, ritirò le dimissioni.
Mussolini sapeva che la monarchia non si sarebbe opposta, affermò il disprezzo per il parlamentarismo, ripudiò la democrazia che era stata “utile ed efficace per la nazione nel secolo XIX, può darsi che nel secolo XX sia qualche altra forma politica che potenzii di più la comunione della società nazionale”. Esaltò esercito e nazione, principale mito del fascismo: “Il nostro mito è la nazione, il nostro mito è la grandezza della nazione. E a questo mito, a questa grandezza, che noi vogliamo tradurre in una realtà completa, noi subordiniamo tutto il resto”.
Il fascismo non salì al potere in seguito a un compromesso ma grazie alla resa dello Stato liberale ricattato da un partito armato.
Si poteva annientare il fascismo? Sì. Si poteva salvare la democrazia? Sì. Si poteva evitare al popolo italiano di vivere la tragedia che la Storia ci ha trasmesso? Sì. Se solo la “marcia su Roma” non fosse stata sottovalutata. E se anziché chinare il capo di fronte alle minacce di chi adottava la violenza come strumento di potere, si fosse mantenuto alto per dire “no” al dispotismo.
Penso alle parole di Levi. Quel che è successo può ripetersi. La Storia dovrebbe insegnare, e invece vedo sottovalutare parole, dichiarazioni, atti violenti. Chi dovrebbe prendere posizioni forti contro tali manifestazioni tace, minimizza, riduce tutto a “folclore”, a “espressioni colorite”, a “imprese di quattro balordi”. Erano “quattro balordi” anche allora. Sappiamo com’è finita.
Errare è umano. Perseverare…
 1
1
Certezza non v'è, e la ragione barcolla

In terra elvetica, precisa, pulita e razionale, certezza non v’è, e la ragione barcolla. Una beffa tremenda per la perfettissima Svizzera.
Sembra il classico giallo: scoperto un cadavere, inizia l’indagine e si trova il colpevole.
Dürrenmatt introduce però elementi che scompongono il disegno: caos e caso (e già i due lemmi accostati creano un bel gioco). Matthäi, genio investigativo, ha promesso alla madre dell’ultima piccola vittima di scoprire la verità. Intuendo l’innocenza del presunto assassino, inascoltato dai colleghi, si mette a indagare da solo. Ha studiato e dato forma a ciò che forma non aveva.
Un uomo uccide ferocemente delle bambine. L’ultima ha lasciato un indizio importante: un disegno che raffigura il gigante dei porcospini. Per Matthäi diventa un’ossessione, e nel folle tentativo di intrappolare l’ignoto killer, usa un’esca, inconsapevole d’esser tale.
Gli ex colleghi, convintisi delle intuizioni di Matthäi, lo appoggiano. Ma
“La nostra ragione rischiara il mondo non più dello stretto necessario. Nel bagliore incerto che regna ai suoi confini si insedia tutto ciò che è paradossale.”
Dunque l’ordine non è di questa terra e l’etica capitola di fronte al fine da raggiungere?
Un accadimento banalissimo sovvertirà la logica, a dimostrazione che casualità e caos possono spezzare l’esile filo che lega la realtà all’intelletto.
È la sconfitta del raziocinio.
Requiem.
Chissà, se solo avessero aperto un giornale. Ma sarebbe stata un’altra storia.
P.S. Noto (con consueto sobbalzo): “L’individuo era pregiudicato. Reato sessuale ai danni di una quattordicenne.”
---------------
“Non era stato condannato una volta per un reato sessuale?” “C’era stato qualcosa con una quindicenne.”




 2
2