
“Amavo i libri, ecco tutto, e il mestiere di libraio mi avrebbe permesso di ricoprirne i muri: avrei potuto immergermi nell’oceano della conoscenza”.
La Maison des Amis des Livres di Adrienne Monnier in rue de l'Odéon a Parigi, vede passare, fra il 1915 e il 1951, scrittori, artisti, intellettuali come Proust, Joyce, Hemingway, Prevért, Rilke, Beckett, Gide, valéry, Claudel, Severini, Apollinaire, Satie, Poulenc e tanti altri. Frequentano la libreria perché lì si vive la letteratura.
Quando Adrienne apre la sua libreria, grazie alla saggia follia dei suoi genitori che le affidano tutto il denaro di cui dispongono, ha ventitré anni e nessuna esperienza nel settore ma nutre un amore smodato per libri e letteratura. Questa grande passione la renderà paladina della cultura a Parigi per quasi quarant’anni.
La Maison des Amis des Livres apre durante la Prima guerra mondiale e attraversa la Seconda, ma è un’oasi felice. Qui, oltre al banco di vendita, ci sono una sala lettura e una libreria di prestito che consente al lettore, previa sottoscrizione di un abbonamento, di portare a casa il libro e, una volta terminato, decidere se acquistarlo.
Per scelta, forse di ordine economico, tratta letteratura contemporanea, e può darsi sia proprio questo ad attirare tanti scrittori celebri e molti ancora sconosciuti.
La sua libreria è giardino delle delizie. È città in cui perdersi e trovarsi. È isola delle meraviglie.
È approdo sicuro per tutti i pazzi per la letteratura come lei.
“Nel mestiere di libraio c'è una ricompensa per le curveé: le visite piacevoli, quelle degli autori e dei veri amanti dei libri. In questi momenti la vita brilla in tutto il suo splendore, la conversazione diviene frizzante e a volte dà una vera e propria ebbrezza.”
È nostro dovere aver cura di quei piccoli mondi che sono le librerie, e dobbiamo tanta, tanta riconoscenza ai loro custodi.
 1
1

Mah... Nella prima metà del libro mi nomina Anna Banti per nove volte nove. Nella seconda metà foto e scritti di Matilde. Fine della biografia. A-ri-mah...
Rimane la curiosità di leggere quella di Anna Banti, biografia.
La signora Matilde meritava di meglio.
Sono stata chiara?
P.S. Capisco i refusi. Ma non vedere che Eleonora Duse e Matilde Serao si incontrano nel 1978 (millenovecentosettantotto), capiamoci.
"Un rapporto speciale, privilegiato, lega Matilde Serao alla divina Eleonora Duse, che conosce giovanissima a Napoli nel 1978".
 1
1

L’amante giapponese: agile sorvolata su tutti i flagelli del XX e XXI secolo. Nessuno escluso.
Fra un looping e un tonneau c’è di mezzo l’amour! Innocente, proibito, tradito, vissuto, incestuoso, azzardato, rubato, segreto, acquisito, omosessuale, infantile, senile, amicale.
Epperò, quello di Alma Belasco, amore, arriva fino alla soglia delle convenzioni. Lì si ferma. Non va oltre. Per non perder le certezze. E il povero Ichimei rimane in posizione “amante”.
Ichimei (il cui nome significa “sopravvissuto”), nato prematuro e dato per spacciato, “per i primi mesi non ebbe un nome”. ‘Tanto non campa’, avranno detto i genitori (che così a lungo l’avevano desiderato), indicando gozzanamente l’infante come “il coso con due gambe”.
Irina Bazili, moldava, ventitré anni, con trauma porno-infantile da superare, sostiene un colloquio per l’assunzione presso l’istituto geriatrico Lark House, nato per accogliere anziani non abbienti, ma abitato da duecentocinquanta benestanti. Tutti bianchi. Sono “liberi pensatori, persone in cerca di un cammino spirituale, attivisti sociali ed ecologisti, nichilisti e qualcuno dei pochi hippie rimasti nell’area della Baia di San Francisco.”
Direttore della struttura certo Hans Voigt, cinquantaquattrenne che confonde il Che Guevara (stampato sulla maglietta di Irina) per Malcom X. E sì che siamo in America. California. Berkeley. Anno 2010. Van bene le favole. Anche eccessive. Però, è più verosimile il fantasma (che non manca) del direttor.
Negli intrecci esistenziali di e fra l’ottantaduenne Alma e la giovane Irina, una miriade di temi focali, spessi e pesanti, rotola come piselli sbaccellati davanti alla TV. Così, con nonchalance.
Fra una piaga e l’altra pesci fuor dell’acqua “rantolano”, cani affamati vagano in “mute”, scarafaggi “nottambuli” scorrazzano.
La voce narrante fa “barbellare” (termine dialettale lombardo) anziché tremare, “bidonare” invece che dar buca o piantar in asso. Mi chiedo perché.
E perché mi chiedo “Nathaniel TEMEVA CHE i due uomini, già in possesso del denaro, POTEVANO benissimo sparar loro…”.
Inezie, che non giovano al già fiacco procedere.
La scorrevolezza della scrittura non basta a reggere una narrazione poco consistente e ancor meno credibile; narrazione che attraversa temi di grande rilievo storico e sociale senza mai soffermarsi per approfondire. È come buttare tanti semi senza coltivarne alcuno.
Rimane un romanzo debole, non certo all’altezza di un nome tanto celebrato.
 1
1

Nella vita io porto il cuore di bronzo,
ma se vi è una cosa che mi indebolisce,
che mi fa struggere, è l’amore per Napoli.
(Matilde Serao, Lettera a Febea)
Matilde era napoletana, Matilde era la sua città.
Il romanzo-inchiesta “Il ventre di Napoli” si apre con forza dirompente, per rispondere all’onorevole Depretis che, dopo aver accompagnato re Umberto nelle strade partenopee, in quel 1884 segnato dal colera, saggiata la lordura e la miseria della povera gente, affermò: “Bisogna sventrare Napoli”.
Efficace la frase. Voi non lo conoscevate, onorevole Depretis, il ventre di Napoli. Avevate torto, poiché voi siete il governo e il governo deve saper tutto. Non sono fatte pel governo, certamente, le descrizioncelle colorite di cronisti con intenzioni letterarie, che parlano della via Caracciolo, del mare glauco, del cielo di cobalto, delle signore belle e dei vapori violetti del tramonto: tutta questa rettorichetta a base di golfo e di colline fiorite, di cui noi abbiamo già fatto e oggi continuiamo a fare ammenda onorevole, inginocchiati umilmente innanzi alla patria che soffre; tutta questa minuta e facile letteratura frammentaria, serve per quella parte di pubblico che non vuole essere seccata con racconti di miserie. Ma il governo doveva sapere l’altra parte: il governo a cui arriva la statistica della mortalità e quella dei delitti; il governo a cui arrivano i rapporti dei prefetti, dei questori, degli ispettori di polizia, dei delegati; il governo a cui arrivano i rapporti dei direttori delle carceri; il governo che sa tutto: quanta carne si consuma in un giorno e quanto vino si beve in un anno, in un paese; quante femmine disgraziate, diciamo così, vi esistano, e quanti ammoniti siano i loro amanti di cuore; quanti mendichi non possono entrare nelle opere pie e quanti vagabondi dormono in istrada la notte; quanti nullatenenti e quanti commercianti vi siano; quanto rende il dazio consumo, quanto la fondiaria, per quanto s’impegni al Monte di Pietà e quanto renda il lotto. Questa altra parte, questo ventre di Napoli, se non lo conosce il governo, chi lo deve conoscere? E se non servono a dirvi tutto, a che sono buoni tutti questi impiegati alti e bassi, a che questo immenso ingranaggio burocratico che ci costa tanto? E, se voi non siete la intelligenza suprema del paese che tutto conosce e a tutto provvede, perché siete ministro?
È inutile sventrare una città per risanarla; per guarirla va curata, Matilde lo sa:
Per levare la corruzione materiale e quella morale, per rifare la salute e la coscienza a quella povera gente, per insegnar loro come si vive - essi sanno morire, come avete visto - per dir loro che essi sono fratelli nostri, che noi li amiamo efficacemente, che vogliamo salvarli, non basta sventrare Napoli: bisogna in gran parte rifarla.
Vent’anni dopo, nel 1904, la città si presenta con un nuovo abito. O così pare. La piazza della stazione non è più grigia e maleodorante: ha la “vastità degna d’una metropoli” con le sue tre ampie strade che si presentano al viaggiatore.
Accedendo al Rettifilo, l’occhio stupisce per l’ampiezza della via, per il suo bel disegno. Ma è unicamente l’occhio distratto a stupirsi, a non comprenderne le piante assenti né lo strazio di quei pochi alberelli gracili e sofferenti di cui nessuno si cura: non il sindaco, non l’assessore dei giardini, non i cittadini. Passando velocemente si nota soltanto la maestosità del Rettifilo e non si vede ciò che maschera. Il Rettifilo ha tagliato in due il ventre di Napoli, “attraversando i quattro quartieri popolari e popolosi di Mercato Vicaria, Pendino e Porto”. È, o dovrebbe essere, l’emblema della solidarietà umana; il Rettifilo aveva il compito di sanare e salvare il popolo napoletano e, grazie allo sguardo fugace, all’aridità di domande, alla mancanza di risposte, alla fretta, alla superficialità, pare veramente ch’esso abbia offerto al popolo ciò che gli abbisognava. Basterebbe volgere gli occhi per vedere uno scenario diverso. Si scorgerebbero così le sordide abitazioni ferite da povertà e vizio. Si assisterebbe a uno spettacolo orrido, fatto di miseria, di cenci avvilenti appesi alle finestre, di umanità abbandonata, disprezzata, dimenticata. Spettacolo doloroso e ingiusto che infrange vergognosamente il sogno di felicità del Rettifilo.
Infine è Napoli, con voce pacata, a esprimersi:
… io ho bisogno di risorgere. Io non solo debbo vivere, ma debbo svolgere tutte le mie forze sociali e individuali: ognuno dei miei cittadini, sia pure il più oscuro, il più ignoto deve aver lavoro, salute, protezione, educazione, e tutti i cittadini e, io, Napoli, debbo prendere il mio posto bello, nobile, forte, nella vita operosa ed efficace moderna.
Servono capitali che possano contribuire allo sviluppo, ma che sia possibile introdurre senza che qualcuno ne metta la taglia. Servono imprese industriali, ove il capitalista possa “collocare onestamente e securamente il suo danaro” e il lavoratore trovare giusto compenso e aiuto sociale. Servono banche che aiutino le iniziative oneste e sottraggano cittadini e industre all’usura.
Tutto deve però esser fatto alla luce del sole, senza accordi dubbi, disoneste concessioni, premi, compensi. Senza corruzioni. Senza guadagni illeciti.
Io invoco il lavoro, invoco le società, invoco le industrie, invoco le banche, che dovranno redimere la mia miseria, il mio ozio e la mia inciviltà: ma tutto questo deve esser fatto in un’altra maniera, non più in quella di prima, in una maniera schietta, leale, franca, in una forma delle più integre, con, una probità perfetta, con quel rigore di coscienza, da tutte le parti, che, in tanto rivolgimento di cose, è la via della verità e della vita.
Un monito, infine, quello di Matilde. Penna autentica, sensibile, coraggiosa:
… Faccia il suo dovere chiunque, non altro che il suo dovere, verso il popolo napoletano dei quattro grandi quartieri, faccia il suo dovere come lo fa altrove, lo faccia con scrupolo, lo faccia con coscienza e, ogni giorno, lentamente, costantemente, si andrà verso la soluzione del grande problema, senza milioni, senza società, senza intraprese, ogni giorno si andrà migliorando, fino a che tutto sarà trasformato, miracolosamente, fra lo stupore di tutti, sol perché, chi doveva si è scosso dalla mancanza, dalla trascuranza, dall’inerzia, dall’ignavia e ha fatto quel che doveva.
Esortazione di ieri, che ancora oggi attende d’essere applicata pienamente.
P.S. Vogliate bene a Napoli. E vogliatene a Matilde.
 1
1

“Quanti mondi riesci a tenere in una mano.
In una manciata di sabbia.”
Elisabeth, con la “S”, trentadue anni, docente con contratto a tempo determinato presso un’università londinese.
Daniel, centenario, vicino di casa. Di Elisabeth è stato babysitter, nonno, amico, maestro. Le ha insegnato l’arte e la vita. E l’amore attraverso il ricordo di Pauline Boty.
Ora dorme Daniel, dorme e sogna. Elisabeth appena può lo raggiunge nella clinica dov’è ricoverato, gli legge un libro, gli parla.
Momento di poesia. Delicata, malinconica, viva. Nonostante la consapevolezza che quando l’ultima foglia si poserà a terra sarà fatalmente inverno.
La vita è caduca. Si sa.
Granelli di sabbia. Microcosmi. Storie minimali.
Le nostre storie. Intime. Esclusive. Immerse nella Storia che ci è madre e matrigna. Presente sempre. Spesso pesante. Storia che talvolta accoglie talaltra imprigiona. O divide.
Qua. Là.
… una recinzione qui, un muro lì, una linea tirata qua,
una linea superata là,
una linea da non superare qui,
una linea che è meglio non superare lì,
una linea di bellezza qua,
una linea di febbre là,
una linea di cui non sai nemmeno l’esistenza qui,
una linea di povertà lì,
una nuova linea di fuoco,
linea del fronte,
capolinea,
qua/là.i>
Un giorno le dita s’apriranno. La sabbia scivolerà giù.
A comporre nuova vita.
A forgiare nuovi mondi.
A plasmare nuove storie.
Magari senza linee. Senza capolinea. Senza qua né là.
Autunno è scrittura veloce, frammentata. Onirica. Poetica. Politica. Attuale.
È vagolare inquieto nel quotidiano che circonda ogni esistenza. È evolversi nell’immobilità dell’attesa. È percorrere la Storia attraverso le parole narrate. È trasmettere il presente. Che, in fondo, è già passato.
“C’è sempre, ci sarà sempre una storia da raccontare. Cos'altro esistono a fare le storie sennò.”

Rataplan!... tamburo io sento
Che mi chiama alla bandiera.
O che gioia, o che contento! I
o vado a guerreggiar.
Rataplan non ho paura
Delle bombe e dei cannoni;
Io vado alla ventura...
Sarà poi quel che sarà.
Luciano aveva da poco imparato a leggere quando papà Atide gli regalò I mille di Giuseppe Bandi (scaricabile gratuitamente qui): . E lui, il Lucianino, ne rimase folgorato. Lesse e rilesse fino a ricordarne molti brani a memoria. Quel volume lo accompagnò nel tempo, e il Risorgimento divenne la sua passione. Oltre a quest’opera, uscita nel 1969 col titolo Daghela avanti un passo! (ripubblicato ora come Antistoria del Risorgimento, col sottotitolo Daghela avanti un passo!), scriverà altri libri con tema il Risorgimento: Da Quarto a Torino, La battaglia soda, Garibaldi, Aprire il fuoco, Ai miei cari compagni.
Antistoria del Risorgimento nacque in realtà come libro per gli studenti della scuola media. Fu l’entusiasmo dell’editore a spingere Bianciardi a reinserire le parti che aveva tolto (ritenendole troppo crude per i ragazzi) e realizzare anche un’edizione per adulti.
Antistoria del Risorgimento è la storia degli anni in cui si fece l’Italia, gli anni delle insurrezioni. Anni gonfi di eventi; taluni bizzarri come lo sciopero del fumo iniziato il giorno di capodanno del 1848 quando, finita la messa, i milanesi presero a passeggiare senza fumare. Per le vie meneghine rimasero gli ufficiali austriaci, unici col sigaro acceso, a osservare il fatto, sbigottiti. Il motivo di questa “azione” è presto detto: sciopero del fumo come forma di protesta contro l’aumento della tassa sul tabacco. La chiamarono “dimostrazione del fumo”. Proseguì il giorno successivo. Immaginabile l’irritazione dell’erario Lombardo-Veneto per il danno economico che tale comportamento cagionava. L’azione sortì una risposta alquanto comica, e diede il via a sonori tafferugli fra cittadini milanesi e soldati austriaci.
O come quando i soldati austriaci si ritirarono, fuggendo dall’enorme cilindro di fascine legate, e bagnate per evitare che s’incendiassero, che gli rotolava addosso mentre gli insorti avanzavano, ben coperti, dietro la “barricata mobile”.
Atti di lotta fuori delle regole.
“Chi ignora le regole della guerra, e fa la guerra, anzi in questo caso la guerriglia, fuor delle regole, contro le regole anzi, del gioco, quasi sempre vince. È come se, durante una partita di calcio, una delle due squadre, ignorando, spregiando le regole del gioco, cominciasse a pigliare la palla con le mani. Vincerebbe. Certo, l’avversario potrebbe sempre protestare, con l’arbitro, che la vittoria è irregolare. Ma nelle guerre non ci sono arbitri che col fischietto impongano il rispetto del regolamento. La storia si è incaricata, poi, di confermarci che le cose stanno esattamente così, anche se non tutti i generali di questo mondo hanno dimostrato di capire la lezione.”
In questo Risorgimento vigoroso, vivace, esuberante, una figura svetta su tutti. Bianciardi la raffigura come “l’elemento popolare”, alla quale egli rivolge tutta la sua partigiana simpatia. Si tratta di Giuseppe Garibaldi, che dall'America “dove era corso a battersi per la libertà di altri popoli” era tornato, deciso a
“menar le mani per la libertà del suo paese, l’Italia. Il 4 di giugno si presentò al re, nel quartier generale di Roverbella: era un uomo di quarantun anni, robusto, di statura non alta (per la precisione, un metro e sessantasei), dall’aspetto piuttosto singolare: lunghi i capelli d’un biondo rossiccio, chiari gli occhi, indossava uno strano indumento, il poncho, che è poi un mantello sudamericano, cioè una coperta con un buco nel mezzo per infilarci il capo. Lo accompagnava un negro alto e membruto, tutto vestito di nero, a cavallo, armato di lancia, di nome Aguyar. Il negro non parlava l’italiano, ma l’altro sì, e con l’accento ligure. Chiedeva al re di permettergli di battersi al suo fianco, con le schiere armate dei suoi volontari. Alcuni di essi erano reduci dal Sudamerica, molti altri si erano arruolati volontariamente in Lombardia e in Liguria, armandosi e abbigliandosi come meglio capitava. C’erano non poche camicie rosse.”
Quante volte ho riletto (fra i tanti che ho trascritto) questo passo. Monito che risuona nella mente, che non dà pace. Almeno a me.
“La verità è che il Risorgimento fece l’Italia quale poi ce la siam trovata noi italiani, lacerata e divisa. Divisa fra italiani ricchi e italiani poveri. Fra italiani del Nord e italiani del Sud. Fra italiani dotti e italiani analfabeti. Tutte divisioni che oggi noialtri italiani, faticosamente, penosamente, stiamo cercando di colmare. Ma per far questo dobbiamo sapere la verità su come l’Italia fu fatta. Dobbiamo insomma studiare sul serio la storia di quel «miracolo» che fu il nostro Risorgimento.”
Caro Luciano, sapessi. Le divisioni che ieri tentaste di colmare, oggi son lacerazioni profonde, il divario è sconfinato, e son cose che non si possono accettare. Sarà che non s’è imparato come l’Italia fu fatta, che non s’è studiata sul serio la Storia, sarà che siamo figli di quella rivoluzione fallita. Sarà la somma di tutto questo e altro ancora, ma qui per cambiar qualcosa servirebbe una novella rivoluzione, prima di tutto culturale. E dimmi tu come si fa a risvegliare i sogni, a riscaldare i cuori incarogniti, disseccati; come si fa a rianimarli.
Non preoccuparti, che lo scoramento passa. L’incazzatura invece resta. Ma è buon segno. È incazzatura sana. Quella che serve persino a ridere.
E domani torneremo a credere, ancora, nell’incanto di un nuovo Risorgimento.
Ciao, Luciano.
Manchi sempre.
P.S. Leggete Bianciardi. Leggetelo. Datemi retta.
 1
1

… la fiamma traballa,
la mucca è nella stalla.
La mucca e il vitello,
la pecora e l'agnello,
la chioccia coi pulcini,
la mamma coi bambini.
(Lina Schwarz)
La vita nelle campagne italiane dell’Ottocento non fu documentata dai contadini. L’analfabetismo glielo impedì. Per averne memoria diretta, attenderemo il 1968, anno in cui Vincenzo Rabito, contadino siciliano classe 1899, dopo aver combattuto contro la condizione di semianalfabeta, scriverà la sua storia battendo con un solo dito sui tasti di una Olivetti Lettera 22.
Falsamente illustrati, esclusi dalle trasformazioni che andavano compiendosi, i contadini vissero in condizioni disumane fra bestie, miasmi malsani e umidità insalubre.
Ci volle l'invasione degli eserciti napoleonici perché nascessero nei nuovi “Stati italiani” istituzioni governative dedicate alla conoscenza di realtà e problematiche delle comunità contadine. S’impostarono commissioni d’igiene, partì una serie d’inchieste e rilevazioni (“non tutte arrivate a compimento”). Riconosciuta l’importanza della statistica come scienza di governo, essa “divenne una disciplina accolta nell’ordinamento delle università e associata all’economia.”
I medici condotti furono incaricati di redigere una “Statistica”. L’indagine svelò l’enorme disparità culturale tra le città e il mondo contadino, soprattutto portò alla luce la sofferenza di questa povera gente, costretta a vivere nel “succidume”, a nutrirsi di niente, a morire di stenti, a passare i mesi invernali nelle stalle, a stretto contatto con le bestie che divenivano fonte di calore.
Contadini, gente invisibile, “classe oggetto”. Popolo infetto, strumento d’arricchimento delle classi dominanti. Stirpe spregiata, sottomessa da borghesia e clero.
Contadini senza sufficienti strumenti per lavorare la terra, impegnati ogni giorno della settimana per dieci, dodici ore; durata che si prolungava di solito oltre le ore di luce solare. La vita degli uomini era dura, quella delle donne spaventosa. Le donne di giorno sarchiavano la terra, piantavano e sradicavano legumi, spigavano, vendemmiavano, coglievano olive, mandorle, fieno. Nelle ore notturne filavano e tessevano, dopo aver “onorato” le faccende domestiche. Le fatiche cui si sottoponevano erano causa di aborti e, spesso, di conseguente sterilità. Delle nascite si occupavano ostetriche improvvisate, incapaci e prive di qualsiasi conoscenza medica mettevano a rischio la vita di madri e figli: “strappano la placenta fuori tempo […], tirano il feto doppio senza raddrizzarlo, comprimono appena nato la testa in tutt’i sensi per rotondarla, spezzano il freno della lingua, conficcano il dito nell’ano, o nella vagina della neonata e molte volte sono causa della loro morte”. I neonati abbandonati presso gli ospizi erano affidati a contadine nutrici che se ne occupavano per guadagnare qualche soldo. I bambini che non morivano entro i primi anni di vita erano destinati a un’esistenza grama: i maschi occupati come garzoni, le femmine a servire o mendicare. Tanto necessaria era la presenza dei piccoli lavoratori nei campi che fu pressoché inutile l’istituzione delle scuole elementari.
L’alimentazione dei contadini era a base di pane, non sempre fatto di frumento: spesso era pane di farina d’orzo crudo e arrostito, oppure polenta. La carne (sulla tavola solo nelle feste solenni) era sostituita dai lupini; quando compariva sul desco di questa povera gente, era il più delle volte carne infetta d’animali morti di malattie pericolose anche per l’uomo.
D’estate, per recuperare qualche denaro, si spostavano con le famiglie: gli uomini andavano a mietere, le donne e i bambini a “spigare”. Per un mese tutti dormivano a “ciel sereno”, e questo non poteva che aggravare malattie come polmoniti e pleuriti, causa di numerosi morti per “febbri perniciose”.
Colera, malaria, tisi, rachitide, scrofola, sifilide, pellagra falcidiavano la popolazione contadina. Madre di tutte le malattie: la miseria.
Durante il secolo XIX i medici condotti produssero rapporti sulle condizioni di vita dei contadini, cercarono di migliorare il loro stato igienico-sanitario, di educarli al rispetto di norme d’igiene fondamentali, di sollevarli dalla loro condizione bestiale.
Nell’immobilità dello Stato e dei ceti più agiati, che temevano la massa contadina. Quando lavoratori della terra, alzata la testa, osarono accendere la fiamma della sommossa, trovarono un altro fuoco a fiaccare e reprimere il tumulto, a sopprimere il seme del socialismo che stava germogliando, perché “Nulla è più pericoloso di una grande idea in un piccolo cervello”. Il cervello ristretto era quello dei contadini, considerati – sotto l’influenza del pensiero lombrosiano - una “anteriore fase dell’evoluzione psichica umana”. Esseri pericolosi, da rinchiudere nei penitenziari o nei manicomi criminali. Da tenere isolati per non propagare “la loro stirpe disgraziata” perché “quel qualunque progresso morale, che l’umanità ha raggiunto in tante migliaia d’anni, si deve […] ad una lenta e continua selezione, per sopravvivenza dei migliori.
Razza inferiore, malattia sociale da combattere senza pietà. “Razza”, nuovo elemento divisivo. Nuova barriera che si erigeva tra il contadino e il resto del mondo. Si apriva la via all’esercizio “illimitato del diritto di vita e di morte come iscritto nella logica della lotta per la sopravvivenza della specie”.
Nel linguaggio degli intellettuali italiani entrò in uso un nuovo lemma per la categoria: “umili”, termine che tanto sdegno suscitò in Gramsci.
“Questa espressione – «gli umili» – è caratteristica per comprendere l’atteggiamento tradizionale degli intellettuali italiani verso il popolo e quindi il significato della «letteratura per gli umili». Non si tratta del rapporto contenuto nell’espressione dostoievschiana di «umiliati e offesi». In Dostojevschij c’è potente il sentimento nazionale-popolare, cioè la coscienza di una missione degli intellettuali verso il popolo, che magari è «oggettivamente» costituito di «umili» ma deve essere liberato da questa «umiltà», trasformato, rigenerato. Nell’intellettuale italiano l’espressione di «umili» indica un rapporto di protezione paterna e padreternale, il sentimento «sufficiente» di una propria indiscussa superiorità, il rapporto come tra due razze, una ritenuta superiore e l’altra inferiore, il rapporto come tra adulto e bambino nella vecchia pedagogia o peggio ancora un rapporto da «società protettrice degli animali», o da esercito della salute anglosassone verso i cannibali della Papuasia” (Gramsci, Quaderni dal carcere)
La classe dirigente non è mai cambiata, e la riforma agraria è questione ancora aperta.
Penso ai volti e ai corpi dei contadini di oggi, così simili a quelli di ieri. Stracciati, magri, spesso scalzi. Lavorano fino a dodici ore al giorno, patiscono e sopportano le stesse angherie. Differenti per pochi particolari: la pelle più scura, una lingua sconosciuta. I contadini di oggi arrivano sognando un lavoro e confidando nei diritti, quelli di ieri partivano verso mete lontane in cerca di lavoro e diritti, ché qui gli erano negati. Sono a fianco di altri esseri umani nati e cresciuti in Italia; quelli che non sono andati via, quelli che sono rimasti accettando di lavorare nei campi in cambio di due soldi, per non morire di fame. Le donne, ora come allora, vivono una situazione ancor più drammatica.
È Storia che ci appartiene. Ma volgiamo lo sguardo altrove. Da sempre.
C’è da vergognarsi.
 1
1

M’avventuro in un futuro prossimo (identico al presente) ove attendo lo schiudersi e il deflagrare delle tante, troppe nefaste sementi che infestano la patria terra grassa e fruttuosa d’ogni bassezza. Nel frattempo il povero professor Prospero viene barbaramente ammazzato sul pianerottolo di casa. Colpevole, il professore, d’essere un intellettuale radical chic.
Sempre il Prospero, papà di Olivia “succhiava le parole come caramelle”, particolare che mi riporta a Hrabal e al suo meraviglioso personaggio, Hanta: “… io infilo una bella frase nel beccuccio e la succhio come una caramella”.
Fra rimandi e frasi a effetto abbasso l’asticella, entro in modalità “lettura da ombrellone a righe”. C’è aria di già letto, e senso d’incompiuto. Personaggi piatti, bidimensionali ma meno interessanti di quelli abbottiani.
Cerco il futuro prossimo. Lo cerco e non lo trovo. Finché arriva Herry Potter. E lì m’incaponisco. Sul futuro prossimo. Ammesso che ci sia.
“Al tempo in cui giocavano insieme (Olivia e il ministro dell’interno), andavano pazzi per Harry Potter. Avevano imparato a memoria tutti e sette i libri, visto e rivisto ogni film e trascorrevano i pomeriggi a trascrivere su un quaderno le formule magiche di Hogwarts”.
E invece di godermi la storia che fo? Leggo e al contempo (s)ragiono sulla produzione potteriana. I libri sono stati pubblicati nell’arco di dieci anni, dal 1997 al 2007; stesso tempo per i film, che sono usciti fra il 2001 e il 2011. Olivia ha 42 anni, l’avventura “Potter” deve interrompersi al massimo con la conclusione della terza media, perché “dopo le medie si erano persi di vista”. Ipotizzando la visione dell’ultimo film nel 2012 (per dar modo di vederlo e rivederlo), Olivia e gli altri compagni potrebbero essere classe 1998. Ci troviamo nell’Italia del 2040? Sarà questo il futuro prossimo? O un po’ più in là? Ché pensare a un futuro prossimo troppo lontano non riesco. C’è quel modo di comunicare via sms che sa di antico già ora, in questo presente settembrino.
E dai! Pensa al contesto politico, sociale, culturale che sono specchio fedele del nostro quotidiano.
Neanche le parole di Olivia rivolte al ministro: “Una volta ti piacevano i libri. Eri tu che sapevi a memoria Harry Potter, non io.”, discordanti con quanto narrato in un capitolo addietro, mi distolgono dalla stramberia di voler collocare temporalmente la storia.
Così la lettura è proseguita cercando indizi sul futuro prossimo perduto.
Infine il sobbalzo (so che gliel’ho facile, non lo dite!).
Leggo: “Il taxi era invaso da Mozart. La Sonata per pianoforte e orchestra K488 volava, il pianoforte polpastrellava domande ripetute più in grande dai fiati e dagli archi.” Passi il polpastrellamento, ma la sonata no! SONATA? SONATA? Non esistono sonate per pianoforte e orchestra! Nemmeno per mandolino e orchestra o bassotuba e orchestra! Non esistono. La sonata prevede un solo strumento, al massimo due. Il concerto è altro, e l’orchestra può farne parte. Sonata e concerto non sono sinonimi. Anche solo digitando “k488” si troverà una miriade d’interpretazioni del CONCERTO mozartiano, mai della “sonata”.
Insomma, al polpastrellamento della “sonata per pianoforte e orchestra” s’è improvvisamente chiuso (senza preavviso) l’ombrellone. A righe.
Fine della storia.
Pensavo fosse amore. Invece era un’idea inesplosa.
P.S. Mi rasserena, nondimeno, il pensiero di non rischiar la vita sul pianerottolo di casa.
 1
1

Il Manga vale il firmamento.
Le carte geografiche mentono spesso, e sono generiche ed elusive; inoltre un medesimo nome può designare una città identica per giacitura e forma a questa che ignoro se concreta, e tuttavia può essere un’altra città, metafisicamente incompatibile. I miei amici, cui chiedo notizie di Ascoli, mi rispondono con sorrisi cauti e studiatamente generici; essi sono convinti che veglia e sonno nella mia vita a fatica si distinguano. Nessuno conosce Ascoli? Nessuno, eccetto me stesso, ma la mia testimonianza non vale. Mi dicono che una corriera vada ad Ascoli. Non posso fidarmi di una corriera, la quale può essere coinvolta in una congiura provinciale, il cui scopo è appunto quello di far credere che Ascoli esista. Non ho mai visto una automobile con targa di Ascoli, ma debbo aggiungere che nulla so di targhe ascolane.
Il 22 marzo (2019) s’è aperta a Palazzo dei Capitani di Ascoli Piceno la mostra pittorica di Tullio pericoli “Forme del paesaggio 1970-2018”; esposizione accompagnata da un catalogo, e da un libretto omaggio intitolato Esiste Ascoli Piceno? edito da Adelphi (uscito il 21 marzo). Si tratta di un breve articolo di Giorgio Manganelli scritto per la rivista “Marka” diretta da Clio Pizzingrilli.
Un piccolo appunto.
Il librino-ino-ino è arricchito da dieci illustrazioni di Tullio Pericoli che sono gioiellini, e un commento dello stesso Pericoli in chiusura del librino-ino-ino. Una piccola perla, nel suo insieme. Ma Esiste Ascoli Piceno? è presente anche in La favola pitagorica (Adelphi), raccolta di cronache di viaggio che Manganelli scrisse per varie testate giornalistiche fra il 1971 e il 1989.
Concludendo, per chi non ha mai letto Manganelli Esiste Ascoli Piceno? è un piccolo assaggio, un bocconcino godurioso, breve, brevissimo. 913 parole, 5.678 caratteri (spazi inclusi).
E il Manga è come le ciliegie, dopo il primo assaggio non ci si ferma più.
Io ve l’ho detto.
 1
1
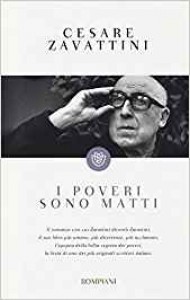
Una riga in otto ore. Una lira, mezzo chilo di pane. Con una riga mezzo chilo di pane: è inebriante. Cinque righe: due chili e mezzo; cinquanta righe, venticinque chili. Quale gioia scrivere e vedersi accumulare panini uno per parola.
Anemone: un panino. Artaserse: un panino. Cappello: un altro panino. Essi svolazzano qua e là e poi si allineano con gli altri.
 1
1

Un corpo senza ombra non occupa spazio, è qualcosa a metà tra il sogno e l’illusione, riporta al mondo dei morti, dove vagolano anime beate o dannate. Un corpo senza ombra è inconsistente, forse inesistente. Destabilizza. Inquieta. Spaventa. Se la nostra ombra avesse vita propria e ci giocasse un brutto scherzo? Abbiamone cura, che non ci abbandoni, stanca di correrci appresso. Amiamola e ci stupirà trasformandosi in ciò che più desideriamo. Restiamo integri, o troveremo un Filippetto che per evitare condanne prenderà a calci la nostra ombra anziché noi. Insomma, le si dimostri affetto, è pur sempre la prima amica che incontriamo nascendo.
 1
1

“La delusione più cocente e insieme più astratta della mia vita, e di molti altri come me, fu senza dubbio il mancato sbarco dei marziani nel decennio tra il 1950 e il ‘60.”
Manganelli li aspettava, uh, se li aspettava! E loro non si sono mai mostrati. Lui ci aveva un debole per i dischi volanti e i suoi passeggeri. Un debole che andava persino oltre la loro inesistenza.
Nell’attesa, il Manga avrebbe anche buttato lì una favola. Tuttavia, per scrivere fiabe (quelle perenni) ci vuole più malvagità che malizia. Perché le fiabe “non si fanno con gli animali benevoli e i re buoni: si fanno con gli orchi, le streghe, i veleni, le vessazioni, i re che decapitano i poveri, le fanciulle che fanno collezioni di rospi già principi, i maghi che insegnano a far morire di morte mala e innocente, la strega che insegna a volare di notte nella stanza del bambino da "cambiare". Per debellare una strega non c’è da farsi illusioni: occorrono bambine streguzze e maschietti maghi; ricordate, tra le fiabe dei Grimm, la strega uccisa dagli zoccoli di ferro rovente che la costringono a danzare orrendamente? E i bambini molto se ne rallegrano: è il loro pane. E la strega messa a cuocere, viva, nel forno? E tutta la popolazione di matrigne, colme d’odio, ansiose di umiliare, frodare, uccidere? E come sono ambigue, feroci, le così dette vittorie del bene.”
I dischi volanti non esistono? (c’è chi replicherebbe: questo lo dice lei!) Il Manga era disposto a crederci, perché “sono improbabili, infinitamente allusivi” e, soprattutto, perché non li aveva mai visti. E crediamoci!, nonostante ci sgomenti il turbamento dell’America in ascolto del messaggio di Orson Welles, nel 1938. Vi ricordate?
Leggiamo la fantascienza. Ridiamo (con giudizio), spaventiamoci e dormiamo male. Facciamoci prendere dal desiderio di varcare il confine della realtà. Dopo averla identificata.
Un giorno passerà la moda degli UFO, ma non quella dell’assurdo, ci avverte il Manga. E ci invita a fare attenzione che, dopo quella degli UFO, non prenda l’ansia della fine del mondo. “Quel panico, quella frenesia che cominciarono quarant’anni fa, in America.”
E le comete? Le comete dall’umorismo sottile e stravagante avranno incontrato gli UFO? Non lo sapremo mai. Non danno confidenza, le comete. Sono esclusive, si pavoneggiano. Forse perché viaggiano, conoscono e sono conosciute. Hanno una vita avventurosa, ma non rilasciano interviste. E non fanno tante chiacchiere, nemmeno dal coiffeur. Chissà se sapremo mai.
Le comete non parlano; e gli aerei se incontrano un UFO tacciono, temendo che li prendano per ubriaconi.
Sicché, attendendo che un UFO atterri o si mostri nel cielo, godiamoci le inferenze manganelliane su automi, astronomia, astrologia, computer, elfi e fate. E telefoni.
A proposito, non è elettrizzante l’idea di telefonare nello spazio? Chiamare una navicella spaziale, chiedere: l’hai incrociato? L’UFO, un UFO, uno qualsiasi, anche piccino, minimo. Financo invisibile! Eh? L’hai incrociato?
Avventuratevi in questa dimensione plurima, sorprendente e acuta col Manga che «non credeva che gli oggetti non identificati fossero realtà» ma, «credeva che la realtà fosse un oggetto non identificato né identificabile».
Buon divertimento.
 1
1

“I libri valgono più dei pazzi, i libri valgono più degli uomini, […] i libri sono muti, parlano e tuttavia sono muti, ecco la loro straordinaria qualità, parlano e tu li senti più rapidamente che se dovessi ascoltarli con le orecchie.”
Nell’aprile del 1927 lo studente Elias Canetti affitta, dopo aver abitato varie camere ammobiliate a Vienna, una stanza fuori città, su una collina oltre Hacking, nella Hagenberggasse. Racconta: “Il panorama mi entusiasmò, al di là di un parco giochi si vedevano lungo il pendio gli alberi del grande giardino arcivescovile e, dall’altra parte della valle, sulla cima della collina di fronte, lo sguardo si posava sullo Steinhof, la città dei pazzi cintata da una muraglia”. Vi rimane per sei anni. Scrive inoltre: “… non devo soltanto la figura di Therese. La vista quotidiana dello Steinhof, dove vivevano seimila pazzi, è stata la spina nella mia carne. Sono assolutamente certo che senza quella stanza non avrei mai scritto Auto da fé.”
Ancora, c’è un fatto che segnerà profondamente Canetti e inciderà sulla genesi di Auto da fé (oltre a dare il via alla sua ossessione sulla massa): il 15 luglio 1927, a seguito della protesta contro l’assoluzione degli assassini di alcuni operai, i lavoratori viennesi sfilano, partendo da varie parti della città, verso il Palazzo di Giustizia. Canetti si unisce a uno di questi cortei. I rivoltosi incendiano il Palazzo. La polizia spara, novanta persone perdono la vita. In una via laterale Canetti s’imbatte in un uomo che geme disperato: “Bruciano i fascicoli! Tutti i fascicoli!”. Canetti, sconvolto, esplode: “Meglio i fascicoli che gli uomini!”. L’uomo non risponde, prosegue nel suo inconsolabile lamento: “Bruciano i fascicoli! Tutti i fascicoli!”.
Quando lo scrittore traccia la sua “Comédie humaine dei folli”, inizialmente chiama Brand (incendio) il topo di biblioteca B., inconsapevole, in quel momento, che nome e destino del personaggio sono legati all’episodio di quel 15 luglio.
Durante l’estate del 1928 e ‘29, a Berlino, il giovane Elias lavora come aiutante di Herzefelde, fondatore della casa editrice Malik; incontra grandi nomi della letteratura e inizia a guadagnare con le traduzioni. E matura un pensiero che non lo abbandonerà più: “il pensiero degli uomini eccessivi e invasati” conosciuti a Berlino.
Rientra a Vienna. Davanti ai suoi occhi, sulla collina, continua a troneggiare lo Steinhof, la città dei pazzi.
Un mondo in frantumi va raccontato con onestà. Ecco come nasce la “Comédie humaine dei folli”, Auto da fé., coi suoi personaggi eccessivi, al limite della follia; uno presso all’altro, ciascuno disgiunto dall’altro. E su tutti lui, l’uomo dei libri. E i libri.
Nel 1931 il romanzo è concluso. Il nome del protagonista è cambiato, il titolo provvisorio è “Kant prende fuoco”. Canetti invia a Thomas Mann il manoscritto, diviso in tre volumi. Pochi giorni dopo i volumi tornano al mittente. Mann si scusa, afferma che “le sue forze non erano sufficienti all’impresa”. È un rifiuto pesante. Non sarà l’unico. Tuttavia, ogni rigetto rafforza in Elias l’idea che il romanzo sopravviverà al tempo.
Nel ‘35, finalmente, Auto da fé è dato alle stampe. Il protagonista ha cambiato ancora nome, ora si chiama Peter Kien.
Kien ama i libri più degli uomini. Vive isolato, vive per i suoi tomi. Odia l’ignoranza. Odia il mondo. Eppure arriva a sposare la gretta Therese, la sua fantesca, dopo averla vista “coccolare” uno dei suoi volumi. È sorprendente come, talvolta, si possa cadere nella rete. Peter Kien e Therese sono due personaggi titanici, rappresentazioni monumentali dell’eccesso. Non da meno sono gli altri personaggi che riempiono le pagine e l’esistenza del professor Kien. Il lettore non può che rimanere intrappolato nella storia, nelle storie. E non può evitare di ritrovarsi, almeno per un attimo, nei panni di Peter.
Auto da fé è un romanzo estremo, abitato da personaggi estremi che si muovono in una realtà scomposta, in contesti piretici, deformati. Deformanti.
Testa senza mondo. Mondo senza testa. Mondo nella testa.
È il libro delle ossessioni. Tragico, crudelmente comico. Grottesco e doloroso. Ma vivo, disperatamente vivo. Vivo come pochi romanzi sanno essere. Nonostante tutto.
Guardo dove, fin poco fa, era il sesto gradino. Mi metto in ascolto. E non dirò cosa odo.
 1
1

Inizio la mia lettura con entusiasmo. Da bambina lessi un libro dal titolo Achille e Patroclo, rimasi talmente affascinata dalla figura di Patroclo che ne conservo ancora il ricordo.
È Patroclo che narra:
Mio padre era un re, figlio di re. Come la maggior parte di noi, non era molto alto e aveva la corporatura di un toro, era tutto spalle. Sposò mia madre quando lei aveva quattordici anni, dopo che la sacerdotessa gli aveva assicurato che sarebbe stata feconda. Era un buon accordo: lei era figlia unica e tutte le fortune del padre sarebbero andate a suo marito.
L’incipit promette bene. Le pagine scorrono. L’intensità va sfumando. Fino a che la mia mente vagheggia sdraio e ombrellone. A righe.
Proseguo. Patroclo racconta, io voglio ascoltarlo! E poi vorrei regalare il libro a una persona cara, appassionata di epica e miti antichi. E per principio non dono un libro che non conosco.
Epperò, i personaggi si fanno meno credibili, la narrazione più cedevole.
Arrivo all’episodio in cui Diomede suggerisce a Licomede di chiedere a Odisseo di raccontare la storia di sua moglie. Odisseo raccoglie l’invito e comincia a parlare. Quando, con una smorfia di disgusto, il re di Argo lo interrompe:
«Sono stufo marcio di ascoltare la storia del tuo letto nuziale.»
Odisseo replica:
«Allora forse non avresti dovuto suggerirmi di raccontarla.»
E qui il sobbalzo. Il re prorompe con:
«E forse tu dovresti inventare qualche nuova storia del cazzo, così non sarei costretto a morire di noia.»
Mi sorge spontanea e improvvisa la domanda: ma il termine “cazzo” quando è entrato in uso? Sarà scritto così anche nella versione in lingua originale? Sarà una botta di colore per rinvigorire la narrazione che s’è un po’ ammosciata? Controllo. L’etimo è incerto, pare che derivi dal nome del maschio dell’oca: l’ocazzo. Liquidata la o, ecco il nome che rappresenta il ben noto organo. Il suo ingresso in società è tuttavia successivo al tempo dei nostri eroi.
Cerco allora il testo originale. La frase si presenta così:
«And perhaps you should get some new stories, so I don’t fucking kill myself of boredom.»
Che tradotto terra terra, la frase suona: “E forse dovresti inventare qualche nuova storia (virgola!), Un volo d’uccello che da là è migrato di qua. Una virgola non farà primavera, ma la differenza sì.
Diciamo che s’è trattato di un fenomeno di fucking translation.
Mi fermo qui.
Tanto basta. E non dite che a me basta poco.
Leggete l’Iliade

Brecht lavorò alla stesura del testo dal 1931 al 1942, mentre era in fuga dalla Germania nazista. L’opera, rimasta incompiuta, è un progetto ambizioso ideato per raccontare la storia del Reich dalla nascita dell’impero fino all’ascesa di Hitler.
Walter Benjamin, tornando da una visita fatta all’amico in esilio, il 27 settembre 1934 scriveva: “… Con Il romanzo dei tuivuole dare una panoramica enciclopedica sulle idiozie dei tellett-ual-in (gli intellettuali); a quanto pare si svolgerà per la maggior parte in Cina. Un piccolo piano di questa opera è già pronto”.
Chi è il tui (nome ottenuto dalle iniziali della distorsione di “intellettuale” in “tellett-ual-in”)? Lo spiega Brecht: “Il tui è l’intellettuale dell’epoca delle merci e dei mercati. Il noleggiatore dell’intelletto”.
Il romanzo dei tui è uno sfogo, un’invettiva contro la stoltezza e l’ipocrisia dei quegli intellettuali disposti a vendersi al miglior offerente. È un’accusa contro gli intellettuali che non riconobbero o sottovalutarono l’avvento del nazismo e che, in seguito, mancarono di avversarlo.
Fra le varie abilità dei tui l’arte del lecchinaggio ha grande rilievo. E se è vero che quasi tutti sono in grado di dare una leccata senza infamia e senza lode è altrettanto vero che l’arte del leccapiedi è qualcosa di più complesso:
“… richiede studio e allenamento. E molta disciplina. Solo con l’esercizio è possibile elevarsi dalle bassezze della leccata corriva, e soltanto quando la perseveranza lascia il posto alla fantasia si diviene veri maestri. Il complimento comune è merce dozzinale, cicaleggio meccanico senza senso né ragione, privo di ogni raffinatezza. Il lecchinaggio praticato come un’arte invece produce espressioni originali, peculiari, profondamente sentite: crea una forma. L’artista completo è duttile, poliedrico, sempre capace di sorprendere. Si studi (ne vale davvero la pena) come il grande Go-teh lodò O-leh: con riluttanza. Una lode di questo tipo ha un valore inestimabile. Davvero ingegnoso è anche travestire da biasimo un elogio. Si rimprovera un generale per l’ardimento che potrebbe strapparlo al suo esercito. All’inizio della Grande guerra i tui ringraziarono l’imperatore esprimendogli tutta la loro rispettosa compassione perché sacrificava la sua gloriosa fama di uomo di pace per assecondare i desideri bellici della nazione. Quando il maresciallo Fank Wi Heng perse la guerra lodarono la sovrana indifferenza con cui affrontò quella disgrazia.
Questo non è più dilettantismo, è già arte.
L’arte del leccapiedi è inoltre, sia detto per inciso, una delle poche che dà di che vivere. Il lecchinaggio nutre il suo discepolo.
Come ogni arte, anche questa ha la sua storia e ha conosciuto epoche di prosperità ed epoche di declino, così come una continua mutazione degli stili.”
Avranno ancora lunga vita i leccapiedi? Pare proprio di sì. Finché esisterà la saliva. Parola di Bertolt.
Scritto corrosivo, satirico, spietato.
P.S. L’elenco “Personaggi e luoghi” svela nomi fittizi e riferimenti storici. Lo stesso autore vi compare come Kin-jen.
Insomma, una penna implacabile, sotto la quale non si salva nessuno.
 1
1

Mai vorrei trovarmi prigioniera di un mega hotel galleggiante, dove nessuno si conosce ma tutti si sorridono, dove migliaia d’infradito colorate sbatacchiano sul pavimento bianco fra cappelli d’ogni foggia e sciarpe che svolazzano al collo di signore eleganti. E dove gli esseri umani si dividono in due gruppi: quello che deve far divertire e quello che deve divertirsi. Il primo stimola il secondo a fare, il secondo s’impegna fino allo spasmo per non perdere neppure un’occasione. E scatta foto scatta foto, gira video gira video, passo a destra passo a sinistra giravolta su le mani giù le mani. Spettacolo serale. Il cibo abbonda, le escursioni attendono. Keep calm che poi finisce, verrebbe da dire, come motto consolatorio.
Comprensibile che il povero turista, in attesa che il pullman conduca tutti alla nave, ascolti la voce dell’addetta al Controllo Folle della Celebrity, di megafono munita che “continua a ripetere instancabilmente di non preoccuparci delle valigie, che ci raggiungeranno più tardi”, trovi “la cosa agghiacciante nel suo involontario richiamo alla scena della partenza per Auschwitz di Schindler’s List.”
Che la Zenith diventi Nadir, a questo punto, non è che un atto liberatorio.
 1
1




 1
1